

In un report dal titolo “Napoleone fermato dallo sguardo di Maria” vi sono due interventi di due studiose che adesso andremo brevemente ad esaminare.
Il primo è quello a cura di Paola Bergamini dal titolo “Maria nella storia” che descrive ciò che avvenni ad Ancona, il 25 giugno 1796 nel Duomo della città intitolato a San Ciriaco e dove è esposta una tela, conosciuta anche come “Madonna del Duomo” :
[…] Il sagrato del Duomo è gremito di persone che lentamente entrano nella cattedrale. Tutti i volti sono turbati, nessuno sorride. Tre giorni prima era arrivata la triste notizia: a Bologna era stato firmato l’umiliante armistizio imposto dai francesi di Napoleone allo Stato Pontificio e una delle clausole prevedeva l’occupazione di Ancona, che significava una sola cosa: incendi, saccheggi, violenze perché in quell’anno di paura le truppe francesi nella loro avanzata così si comportavano. Gli anconetani terrorizzati avevano chiesto al vescovo, il cardinale Vincenzo Ranuzzi, l’apertura dell’urna del loro beato vescovo Antonio Fatati per impetrarne la protezione. Il Cardinale aveva acconsentito. Tra le navate della cattedrale si sente solo il mormorio delle preghiere. Francesca Massari, una vedova trentenne, si inginocchia nella cappelletta costruita da Luigi Vanvitelli e prega davanti al dipinto che tutti chiamano la Madonna del Duomo. Mentre si fa il segno della croce alza gli occhi e ha un sussulto: la Madonna apre e chiude gli occhi [..] .
A seguito di ciò venne effettuata un apposita inchiesta ufficiale il 6 luglio […] con la ricognizione di tre periti: i pittori Francesco Ciaffaroni di Fano, Giuseppe Pallavicini di Milano e Pietro Antonio Meloni. Viene tolta la cornice e il quadro viene analizzato per verificare che non ci sia un qualche artificio. Nulla. Anzi, sotto i loro occhi il prodigio si ripete. Vengono chiamati due scienziati: i due fisici anconetani Lodovico Tessari e Michelangelo Calvani. L’esito è il medesimo: non può essere frutto di allucinazioni collettive perché il prodigio si ripete troppe volte in tempi e luoghi diversi davanti a centinaia di persone[...]
Dopo questa analisi la studiosa Paola Bergamini fa emergere un aspetto antropologico con la descrizione di solenni processioni ed il quadro mariano trasportato in giro per la città dorica.
Prosegue la studiosa evidenziando che […] il processo canonico del fatto miracoloso, iniziato il 6 luglio, terminò il 25 luglio 1796, ma gli eventi politici e bellici che seguirono impedirono il completamento della procedura. Solo nel 1845 il secondo processo accertò definitivamente la verità dei prodigi accaduti tra il 1796 e il 1797: la Madonna del Duomo, Regina di tutti i Santi, venne acclamata Patrona di Ancona. Anche la Santa Sede riconobbe ufficialmente il miracolo […] (4)
Ricordiamo anche che […] Molti cittadini ebrei si rifugiarono nella città di Ancona, dove vigeva l'amministrazione napoleonica [...] (5)
L'altro insert è a cura di Paola Ronconi dal titolo “Viva Maria !” che va ad esplorare alcuni accadimenti avvenuti nel Granducato di Toscana: […] Si era, inoltre diffusa la voce che il comando francese volesse sequestrare e distruggere l’immagine della Madonna del Conforto, - un quadretto di coccio verniciato, tanto caro agli aretini - con la motivazione che «serviva al clero per fanatizzare il popolo». Riguardo a questa immagine, ogni 15 febbraio, migliaia di aretini si recavano nella cappella a lei dedicata per renderle omaggio e ricordare la sera del 15 febbraio 1796, quando la modesta immagine di ceramica - detta Madonna di Provenzano di Siena -, annerita per il fumo, improvvisamente divenne bianca davanti agli occhi sconcertati di quattro popolani che stavano pregando in una taverna di via Vecchia di San Clemente ad Arezzo. Si aprì subito il processo per verificare l’autenticità del miracolo e Arezzo divenne ben presto meta di pellegrinaggi […] (6)
Nel report dello studioso capitolino Andrea Pollet sono analizzate diversi episodi avvenuti a Roma a far data del 9 luglio 1796 quando vi era il sentore della minaccia delle armate napoleoniche nei confronti dello Stato Pontificio. E tale prodigio, cui ne fecero seguito altri venne interpretato come un sinistro presagio.
Dei numerosi eventi che ebbero a verificarsi, prosegue Andrea Pollet «Le madonnelle che la Chiesa di Roma ufficialmente riconobbe aver mosso gli occhi sono le seguenti»:
[…] la Madonna dell'Archetto, in origine situata sotto un arco in uno stretto vicolo tra via di San Marcello e via dell'Archetto, non lontano da piazza di Trevi. Fu la prima madonnella ad aver mosso gli occhi […] ;
[…] la Madonna della Pietà, in vicolo delle Bollette, più vicino ancora alla Fontana di Trevi. Anche questo dipinto è abbastanza ben conservato. Nell'iscrizione latina della targa sottostante si legge: "il 9 luglio 1796 ella posò i suoi occhi sui loro cuori, mostrando loro la grandezza delle sue opere […] ;
[…] la Madonna del Rosario in via dell'Arco della Ciambella, dietro il Pantheon […] ;
[…] la Madonna Addolorata, in piazza del Gesù, alle spalle di piazza Venezia […];
[…] la Madonna della Provvidenza, sull'angolo di via delle Botteghe Oscure adiacente a largo di Torre Argentina […] (7)
Una piccola edicola votiva ubicata nella zona di Borgo Pio non riscosse tali riconoscimenti ed in un sonetto satirico da parte di Giuseppe Gioachino Belli viene menzionata a seguito di alcuni episodi di colera avvenuti a Roma (1835), dal titolo “Semo da capo” , rifacendosi ai vari episodi verificatesi a Roma a far data del 9 luglio 1796:
[…] Currete, donne mie; currete, donne,
a ssentí la gran nova c’hanno detto:
c’a la Pedacchia, ar Monte, e accant’a gghetto
arïoprono l’occhi le Madonne [...] (8)
In ambiti locali piace ricordare alcuni episodi posti al bivio tra tradizione religiosa ed antropologia analizzando quanto pubblicato sul numero 15 del Monitore Napoletano di venerdì 18 aprile 1806 a riguardo il viaggio di Giuseppe, fratello maggiore di Napoleone Bonaparte, nella provincia reggina. Su tale organo si stampa, in data 25 aprile 1806 viene riportato che […] fra le popolazioni accorse da luoghi al passaggio del Re, che hanno vivamente eccitata la sua sensibilità, e fissata la sua attenzione, vi è stata quella di Mammola. Uomini e donne di questa terra in numero di presso a tre mila si son presentati sulla strada con corone di spine sul capo, piangendo, battendosi il petto con pietre rotonde [...] (9)
Tale nota mette in evidenza un dato storico-antropologico importante, in quanto notizie relative all’esistenza di confraternite dei “battentes” o “fustigantes” nella provincia reggina se ne hanno soltanto alcuni secoli prima. Infatti ciò si può evincere dalla lettura de “La pietà popolare in Calabria” di M. Pretto che parla dell’esistenza presso la Chiesa di S.Gregorio di Gerace,ed anche di altre confraternite di battenti presso Roccella Jonica:
[…] nel 1472, nella bolla concessa dal vescovo di Squillace alla confraternita di S.Caterina di Guardavalle (CZ) si legge che le confraternite dei disciplinati erano " in multis Regni partibus […]
[...] nella seconda metà dello stesso secolo viene attestata l'esistenza dei disciplinati nella chiesa di S.Gregorio di Gerace. ... Nel 1500 sono esistenti (e quindi la loro origine e più antica) le confraternite dei battenti a Roccella Jonica […] (10)
Tali esperienze sono analizzate in un altra pubblicazione dove: […] nel XIV e XV secolo si possono osservare molte congregazioni di disciplinati anche nell'Italia Meridionale (battentes o fustigantes) che effettuavano tali riti anche in pubblico, soprattutto durante il periodo di Passione [...] (11)
Dalle suggestioni collettive, profondo credo religioso, propaganda, passiamo alle presenze incorporee o a quelle serie di circostanze legare ad apparizioni di quelle entità conosciute come fantasmi.
Certo, ci fermiamo solo ai fatti di cronaca o alle tradizioni orali che sono giunte fino a noi e nello specifico riguardano le figure di Gioacchino Murat e di Napoleone Bonaparte.
A riguardo il Re di Napoli c'è da evidenziare che non vi sono notizie certe ed esatte a riguardo il luogo della sepoltura.
A tal proposito ci sono diverse letture a tal riguardo.
Alcuni ritengono che i resti siano posti in una fossa comune della navata centrale della Chiesa di San Giorgio in Pizzo Calabro.
Di recente sono stati effettuati anche dei saggi che non hanno portato a nessun risultato, così come non vi è traccia della cassa che conteneva il corpo dello sfortunato Re di Napoli, fucilato nella cittadina napitina, dopo un processo sommario il 13 ottobre del 1815.
Un'altra corrente di pensiero è orientata alla sepoltura di Gioacchino Murat in una fossa comune nel locale cimitero.
Altri invece sostengono che il corpo sia stato gettato in mare e la testa recisa sia stata fatta recapitare a Ferdinando di Borbone.
Addirittura c'è un'altra teoria secondo la quale Gioacchino Murat sia stato sepolto nella Chiesa di San Francesco a Gerace, in provincia di Reggio Calabria).
Tradizione popolare ci tramanda di strane presenze, rumori di catene, strani lamenti, riconducibili a Gioacchino Murat, avvertiti nella Chiesa di San Giorgio che nel castello di Pizzo.
Sempre secondo la trazione orale si afferma che per un certo periodo di tempo successivo a quel 13 ottobre, alla stessa ora e allo stesso giorno di quando la flotta del re venne sorpresa dalla tempesta, uno strano fenomeno atmosferico si verificava puntualmente con lampi e tuoni: era "la tempesta di Giacchinu".
C'è anche da rilevare le differenze di due realtà eterogenee e distanti tra di loro: chi aveva conosciuto l’illuminismo e chi invece aveva ereditato quelle tradizioni stratificate nel corso dei secoli e che apparivano […] inconcepibili e e retaggio di fanatismo e superstizione […] (12), così come riportato dalla corrispondenza epistolare dei militari napoleonici.
DI RECENTE è stata pubblicata una notizia sul Messaggero Veneto, edizione di Udine del 29 settembre scorso, articolo a firma di Renato D'Argenio, viene riportata la notizia della quarta apparizione di Napoleone Bonaparte in quel di Udine. (13)
Mercoledì 28 settembre la sua ultima apparizione sotto la Loggia del Lionello verso le 7.30: il fantasma di Napoleone Bonaparte è apparso quattro volte in municipio a Udine dal 2014 a oggi.
Ma oltre ad alcune delle cifre inerenti alle "verità, miti e credenze" del periodo napoleonico che sono state oggetto di analisi nella conversazione culturale di oggi , ve ne stanno altre che ebbero a sfociare, in situazioni estreme, nel rituale dell'antropofagia.
Quella pratica di sopravvivenza, non risulta nuova, in quanto, per una serie di circostanze logistiche, diventando amara necessità, ha una sua letteratura alquanto consistente che và di pari passo con episodi legati alla miseria,carenza di cibo.
Tali tristi circostanze sono presenti in diverse epoche che vanno dalla prima crociata (1098), così come riportate dal cronista Rodolfo di Caen nel "Gesta Tancredi Hierosolymitana" , alla grande carestia avvenuta durante il biennio 1315-1317.
Durante il periodo travagliato della Rivoluzione partenopea del 1799 si verificarono una serie di episodi come riportato da alcuni saggi storici come quelli di De Nicola e Marinelli rifacendosi ai fatti di cronaca che si registrarono per le vie di Napoli nella giornata di mercoledì 3 luglio: [...]I tradimenti scoverti ieri hanno eccitato nuovamente il furore del popolo, son ricominciati gli arresti e i saccheggi. E’ degno di esser notato che fu veduta ieri una cosa orrorosa a dirsi, ma che fa conoscere che cosa sia l’uomo. Essendosi brugiati i corpi di due Giacobini, il popolo furioso e sdegnato, ne staccava i pezzi di carne abbrustolita e li mangiava, offrendoseli l’un l’altro fino i ragazzi. Eccoci in mezzo ad una città di cannibali antropofagi che mangiano i loro nemici [...]. (14)
[…] Le Truppe a Massa unita col Popolo principiarono a tumultuare su supposto che alcuni ufficiali, per sacrificarli, dentro gli cartucci vi mettevano carbone polverizzato invece di polvere, e nocelle invece di palle. Furono perciò presi per questo supposto tre ufficiali fedeli, furono strascinati, ed uno di essi fu squartato verso l’ultimo di Toledo, a mano sinistra, prima di giungere alla Chiesa di S. Ferdinando, e mezzo fu bruciato, e l’altro restante mezzo abbrustolito fu portato vendibile per le piazze di Napoli, ridotto a pezzetti, a chi se ne comprava un poco, e se lo mangiavano. Le sue parti pudenti attaccate ad una lunga mazza erano portate in trionfo per Napoli. Cosa da non credersi, ma vera però, e veduta da me stesso. Non erano rare queste scene di orrore e raccapriccio [...]. (15)
Ma anche nel novecento altri eventi di tale genere come la carestia verificatisi in Russia nel biennio 1921-1923, l'assedio di Leningrado (1941), durante la conquista da parte dell'esercito finnico della Carelia orientale (golfo di Finlandia), il 1° novembre del 1941, nel villaggio di Maaselkä si verificarono altri atti di cannibalismo, questa volta interessarono i soldati finlandesi che si cibarono dei resti dei soldati russi.
Ma altri episodi sono legati ai diversi naufragi, ma anche a quanto avvenne nel 1972, quando, a seguito di un disastro aereo avvenuto nell'area delle Ande, i sopravvissuti di una squadra di rugby uruguayana, restando isolata, per oltre due mesi e privi di viveri, si nutrirono dei resti dei cadaveri.
Dopo questa breve premessa, ritorniamo al periodo napoleonico per entrare nello specifico agli aspetti di antropofagia che vanno a concludere la conversazione odierna.
Anche in quel caso, campagna di Russia 1812, carenza di cibo, atti di cannibalismo.
Prendiamo ad esempio due saggi di recente pubblicazione.
"Marcia fatale 1812 Napoleone in Russia" a cura dello storico statunitense, di origini polacche Adam Zamosky, narra nel suo saggio di diversi atti di cannibalismo, come quelle inerenti a:i prigionieri russi [...] si cibavano dei cavalli morti che trovavano ai bordi della strada e si ridussero, a detta di alcuni, a mangiare i propri compagni morti [...] (16)
A riguardo i soldati della Grande Armée, dopo l'utilizzo dei resti di cavalli morti, gatti, cani (17) ebbero a registrarsi tristi episodi di antropofagia, come annotati dal [...] generale Langeron, che seguì la ritirata tra la Beresina e Vilnius, non assistette a episodi di cannibalismo, ma vide morti dalle cui cosce erano state tagliate strisce di carne per quel motivo [...] (18), ma anche [...] mentre a migliaia congelavano e alcuni si abbandonavano ad atti di cannibalismo intorno a Plescanicy la note del 30 novembre [...] (19)
Nell'altro saggio di Sylvain Tesson "Beresina, in sidecar con Napoleone" vi è una descrizione più cruda: [...] quando non ci furono più cavalli, gli uomini si mangiarono tra loro. Negli archivi abbondano le testimonianze di cannibalismo e anche di autofagia, ma i relatori evitano di affrontare l'argomento tabù. Bourgogne un giorno si rifiutò di accompagnare un sottoufficiale portoghese a vedere i prigionieri russi che si divoravano l'un l'altro. E quegli scheletri dai volti imbrattati di sangue che derubavano i compagni caduti sul campo dell'orrore, che frugavano tra i loro stessi cenci per rosicchiarsi i moncherini che tremavano all'idea di finire sotto i denti dei compagni, erano, come scrive il capitano François,«gli stessi che sei mesi prima facevano tremare l'Europa» [...] (20) La parola è passata ad Antonino Megali che ha relazionato su “Reliquie e feticismo dopo la morte di Napoleone”, che ha esordito affermando che nonostante la sterminata bibliografia su Napoleone e la sua famiglia e parentela (conta centinaia di migliaia di volumi), non mancano nuove scoperte, revisioni e interrogativi che destano interesse.
Ogni anno – continua Megali – milioni di turisti e semplici curiosi, a Parigi, vanno a visitare il complesso de Gli Invalidi ex Ospedale-ospizio dove ufficialmente riposa Napoleone. Si racconta che anche Hitler appena entrato nella città francese volle fare una visita alla tomba togliendosi il cappello portandolo al petto, gesto mai fatto in altre occasioni. Eppure tanti misteri avvolgono quella tomba giunta in Francia nell’autunno 1840.
La morte avvenuta il 5 maggio 1821 a Sant’Elena sperduta isola in territorio britannico, secondo alcuni fu il risultato di un avvelenamento. Esami tossicologici eseguiti in epoche diverse su ciocche di capelli hanno evidenziato una notevole presenza di arsenico. Ufficialmente l’Imperatore è morto per tumore allo stomaco- dopo un’iniziale diagnosi di infiammazione al fegato- che fra l’altro giustificava la posizione della mano tra i bottoni dell’abito proprio all’altezza dello stomaco.
Coloro che sostengono l’ipotesi dell’avvelenamento ritengono colpevole il fedelissimo conte Charles Tristan de Montholon. Per questioni di gelosia dato che sua moglie consolava l’Imperatore durante l’esilio e anche perché dalla sua morte sperava di ricevere in premio una cospicua somma di denaro per averlo seguito fino alla fine.
Il veleno sarebbe stato prelevato da quello usato contro i topi e versato nel vino riservato all’Imperatore e che essendo molto caro solo lui beveva.Ripartiamo da quel 5 maggio 1821. Il giorno dopo il dottor Francesco Antommarchi, medico che l’aveva assistito, eseguì l’autopsia presenti sette medici britannici e altri testimoni (i ferri usati sono conservati oggi al Museo di Storia della Medicina di Parigi). Il corpo fu disteso su un tavolo di biliardo. Non fu aperta la scatola cranica per l’osservazione del cervello, per l’opposizione del Governatore britannico Hudson Lowe.
Antommarchi preleva cuore e stomaco e li pone in un vaso d’argento riempito di alcool , disubbidendo così a Napoleone che aveva chiesto l’invio del suo cuore a Maria Luisa. Il medico asportò poi due pezzi di costole, dandone una in dono al sacerdote che aveva somministrato l’estrema unzione, l’abate Vignali e l’altra al signor Coursot cuciniere. Antommarchi recise anche l’organo genitale di Napoleone alla radice.
Il pezzo fu consegnato al sacerdote Vignali cosa che rende ancora più strano il gesto. Il pezzo fu poi venduto dai discendenti a una ditta americana e poi a un libraio di New York. Nel bicentenario della nascita sotto la denominazione di “ Reliquia Napoleonica” fu messo all’asta a Londra. Non raggiunse il prezzo minimo di trentamila sterline e tempo dopo in un’altra asta se l’aggiudicò un benestante del New Jersey. Infine fu acquistato da un urologo collezionista di reliquie, il dottor John Kinsley Lattimer, professore della Columbia University di New York e depositato in una cassetta nella stessa clinica universitaria.
Proseguiamo nel racconto dell’enigma del dopo morte di Napoleone ricostruito per alto dal giornalista Antonio Castronuovo con bravura e ironia nel volume Ossa, cervelli, mummie e capelli edito da Quodlibet. La prima sepoltura fu a Sant’Elena in una tomba molto modesta posta in un luogo circondato da una semplice palizzata che aveva comunque una garitta per la guardia d’onore senza però che fosse scritto alcun nome.
Ai sostenitori della morte dell’Imperatore per avvelenamento, si oppongono i sostenitori della sostituzione del cadavere nella tomba posta nella valle dei Gerani a Sant’Elena, ritenendo che quello autentico sarebbe stato inviato a Londra.
Che poi era il timore espresso da Bonaparte qualche mese prima di morire:” Ho desiderato più volte la morte. Non la temo. Per me morire entro quindici giorni sarebbe una fortuna. La sola cosa da temere è che gli inglesi vogliano corservare il mio cadavere e seppellirlo a Westminster”. Il corpo fatto passare per quello di Napoleone sarebbe quello del corso Leonetto Franceschi Cipriani, uomo di fiducia sepolto a Sant’Elena, morto per una non meglio specificata “infiammazione dell’intestino, e della cui tomba non si ebbero più notizie.
Nel 1840 Luigi Filippo decide di ripotare in Francia-anche per ragioni politiche- le spoglie dell’Imperatore. Parte il vascello La Belle –Poule e il 15 dicembre la salma tirata da 16 cavalli passa sotto l’Arco di Trionfo e lungo i Campi Elisi. In quel momento si dissolve la nebbia e compare il sole. Al passaggio della bara risuonò ancora una volta il grido” Vive l’Empereur”.
Solo vent’anni dopo fu accolta in un sarcofago di porfido, ma ancora una volta senza nome. Ma su che cosa fanno capo quelli che sostengono la sostituzione del cadavere? Sulle testimonianze di chi presente all’inumazione fu poi presente all’esumazione. Notevoli le sorprese. Già subito dopo la morte il cadavere era in decomposizione ora appariva ben conservato, addirittura “con parvenza di vita” come qualcuno sosterrà. Ancora la punta degli stivali è aperta e fuoriescono unghie lunghissime.
La posizione tra le due osservazioni erano diverse:” Ora le gambe del cadavere erano piegate, mentre prima erano distese. Sul volto barbe e capelli erano ricresciuti, nonostante fosse stato completamente rasato e i vasi contenente cuore e viscere risultavano cambiati di posto.
Infine nel 1821 le casse erano quattro, poi erano diventate tre. Le decorazioni sepolte con Napoleone non erano le stesse trovate più tardi.
Durante il ritorno della salma in Francia un ufficiale della nave prese una ciocca di capelli lunga ben otto centimetri ( il cadavere ricordiamo era stato rasato a zero) e un chirurgo prese un pezzo di pelle dal viso dell’Imperatore oggi conservato nel museo dell’Armée a Les Invalides.
Il fratello di Napoleone, Girolamo, sosteneva che con tutti i capelli del morto in circolazione si poteva realizzare un parrucchino.
Un’altra ciocca è a Parigi, presso l’Ambasciata della Gran Bretagna in un globo di vetro a breve distanza da altri capelli conservati che appartenevano al suo nemico Wellington. E un’altra parte di capelli l’ebbe Elizabeth Balcombe Abell, la Betsy amica durante l’esilio. Quando la ragazza appena tredicenne incontrò Napoleone si aspettava di vedere un orco, dato che le balie inglesi usavano il nome sinonimo di mangia bambini:
Bimbo, bimbo, egli è un gigante
Alto e nero come il campanile di Rouen
E a pranzo e cena, stai pur sicuro,
Tutti i giorni si ciba della gente cattiva.
La ragazza comunque frequentò poi Napoleone e si dice che la semplice amicizia si trasformò in qualcosa di diverso. A proposito di capelli ricordiamo che nell’ottocento non era un’eccezione distribuire ciocche dei morti agli amici che partecipavano al funerale. Per concludere e per dimostrare che di Napoleone non si è buttato mai niente, è segnalata la comparsa di un dente canino, estratto da un dentista nel 1817 e poi comparso nel 2005 in Inghilterra e poi venduto a 12000 euro.
Per risolvere il dubbio- avvelenato o sostituito-forse basterebbe eseguire l’esame del DNA sui pezzi presi dal cadavere durante il viaggio verso la Francia. Ma le autorità francesi si sono sempre opposte, quindi resta aperto il dubbio sulla reale presenza in quella tomba.



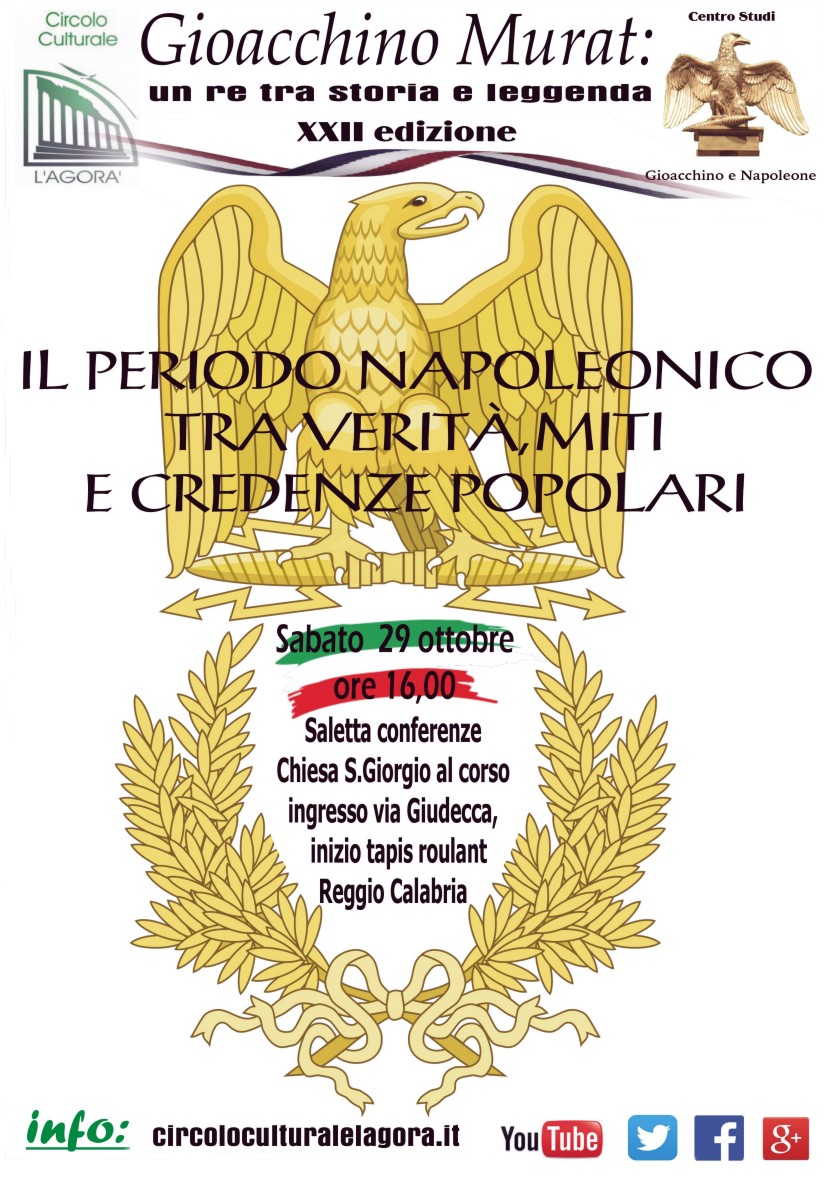



(1) Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel”, 22 maggio 1799
(2) http://www.circoloculturalelagora.it/5maggio_14.htm
(3) V.MESSORI-R.CAMILLERI, “Gli occhi di Maria” ,BUR, 2003
(4) P. BERGAMINI “Maria nella storia” in http://www.tracce.it/?id=266&id2=239&id_n=6809
(5) http://www.circoloculturalelagora.it/5maggio_14.htm
(6) P. RONCONI, “Viva Maria !” in http://www.tracce.it/?id=266&id2=239&id_n=6809
(7) A. POLLET, “Le madonnelle prodigiose” in: http://roma.andreapollett.com/S2/romac13i.htm
(8) M. TEODONIO " Belli, tutti i sonetti romaneschi ", pagina 30, Newton, 1998
(9) Il Monitore Napoletano, ASRC;
(10) M. Pretto, "La Pietà popolare in Calabria" , Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 1988, pag. 290
(11) F. Ferlaino, "Vattienti", Qualecultura Jaca Book, Decollatura,1991, pag. 202;
(12) http://www.circoloculturalelagora.it/murat_15.htm
(13)http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/09/28/news/napoleone-bonaparte-e-tornato-a-udine-fantasma-in-municipio-1.14167554?refresh_ce
(14) C. DE NICOLA, “Diario napoletano (1798-1825)”, Napoli, 1906, vol. I, pag.277;
(15) D. MARINELLI, “La caduta di Napoli”, La città del sole, Napoli, 1998,pp. 8-9:
(16) A.ZAMOYSKI, "Marcia Fatale, 1812 Napoleone in Russia", UTET, 2014, pag. 350;
(18) A.ZAMOYSKI, citato, pag. 427;
(19) A.ZAMOYSKI, citato, pag. 428;
(20) S. TESSON, "Beresina, in sidecar con Napoleone", Sellerio,2016, pag. 95;