

Si è svolta nella sala conferenza dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria la settima edizione della giornata di studi "Pirateria turchesca sulle coste della Calabria Ultra".
La manifestazione è stata organizzata dal Circolo Culturale “L'Agorà” in collaborazione con l'Archivio di Stato di Reggio Calabria.
Piace evidenziare che l'incontro è stato inserito nel palinsesto della XIV edizione della Settimana della Cultura organizzata anche quest'anno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Tale serie di iniziative (14-22 aprile) si volgono in contemporanea su tutto il territorio della penisola italiana con diverse iniziative, aventi vario target che vanno dalla convegnistica, alle visite guidate, mostre, concerti.
Per nove giorni si svolgono in diverse location, quali musei, aree archeologiche, biblioteca statali ed archivi.
Ha aperto i lavori la direttrice dell'istituto culturale Mirella Marra che ha evidenziato l'importanza dell'incontro per la storia del territorio e nel contempo ha voluto ringraziare il docente universitario per la sua presenza alla tavola dei relatori.
Tra l'altro ha voluto tributare un ringraziamento a nome dei reggini per un'altra sua pubblicazione relativa alla città di Reggio Calabria e nello specifico insieme alla professoressa Currò. (1)
Tale pubblicazione rappresenta un punto di riferimento sia per gli studenti che per i ricercatori che frequentano l'Archivio di Stato.
Ritornando al tema della giornata la direttrice dell'Archivio di Stato ha ricordato ai presenti che vi sono una serie di documenti che riportano notizie relative alla peste e dei principi di peste che si sono succeduti e che in varie epoche hanno colpito la città di Reggio Calabria.
A riguardo tale argomento è stato messo a disposizione dei presenti un protocollo notarile che testimonia tale presenza ed attraverso tale documentazione si hanno notizie della peste sul territorio. Il documento datato Reggio, 2 settembre 1656 riporta che“Domenico Genoese e notar Livio Laganà, deputati della salute di Reggio, dichiarano che durante il mese di agosto, concordemente con i Sindaci, avevano stabilito che di notte si potesse pescare dalla Guardia di cavallari di Ravagnisi a quella della Guardia di Pentimeli seu delle Pietre Negri. Essendo sopraggiunto, però, il pericolo di contagio della peste, tanto sono state trovate diverse sorte di robbe mobili che ha buttato il mare nella Marina delli Junchi ... Non senza gravissimo pericolo e suspetto di infettarsi la nostra Città, i Deputati alla salute invitano i Sindaci a vietare alli patroni di tutte le sciabache come di qualsivoglia altra sorte di piscate in tempo di notte in nessuna parte delle Marine di questa nostra predetta città sotto formidabile pena, come è solito farsi nei tempi di suspetto di contaggio”. (2)
Dalla lettura di tale documento si evince a chiare lettere il forte timore per tale morbo,il divieto della pesca notturna nel tratto di mare riportato nel documento notarile in argomento.
Dall'uso delle parole e del linguaggio riportate su tale atto risulta chiaro quanto fosse il terrore nei confronti della peste, tra l'altro come riportato dai Deputati alla Salute in tale protocollo notarile.
Il Presidente del Circolo Culturale “L'Agorà”Gianni Aiello nel corso del suo intervento ha voluto ringraziare l'illustre ospite per aver citato nella sua pubblicazione "I porti della peste" le ricerche cronologiche che tra l'altro si trovano nell'apposita pagina web del Circolo Culturale L'Agorà, denominata CRONOLOGIA, dove vengono riportati diversi avvenimenti suddivisi per anno, mese e giorno.
Tra l'altro - prosegue Gianni Aiello - nella home page del nostro sito internet vi è una link cherimanda alla pagina CITAZIONI dove sono riportati diversi saggi di vario target che citano la nostra Associazione.
Ritornando al tema dell'incontro il Presidente del sodalizio organizzatore ha tracciato brevemente all'uditorio il percorso ed i contenuti delle precedenti edizioni .
La parola è passata alla ricercatrice universitaria Elena Gugliuzzo che il volume di Giuseppe Restifo "I porti della peste. Epidemie mediterranee tra Sette e Ottocento" (Mesogea, Messina 2005, pp. 212) si presenta come una sorta di crociera sui generis nel Mediterraneo centrale d’età moderna. L’autore percorrendo le varie rotte ci conduce di porto in porto: da Marsiglia a Messina e Reggio, da Split a Malta, da Corfù a Tunisi, a Mallorca. Ma fare ‘storia della peste’ significa fare storia della società.
La peste viene analizzata dall’autore come “cassa di risonanza delle tensioni sociali, anzi come laboratorio in cui possiamo assistere, in uno spazio di tempo limitato, al sorgere di azioni individuali, di piccoli gruppi, collettive, che indeboliscono o scuotono i cardini dell’ordine sociale, ovvero che tentano di mantenerlo o di restaurarlo” (A. Pastore, 1991)
L’intercettazione dei traffici marittimi presuppone la rottura delle barriere, di qualsiasi natura esse siano. Nell’ambito dei cosiddetti traffici ‘patologici’, malattie confinate per un certo tempo in determinate regioni possono ‘esorbitare’; in particolare ci si espone al rischio del contagio pestifero. Quanto accade nel Mediterraneo centrale fra il 1720 ed il 1820 ne è la prova: l’apertura dei porti di Marsiglia, Messina, Split, Malta e Tunisi alle merci e uomini provenienti dal Levante porta allo scoppio di devastanti episodi di peste.
Come ha sottolineato Daniel Panzac, soprattutto chi frequenta il Levante e Barbarìa naviga “sotto la
minaccia quasi permanente della peste che potrebbe manifestarsi improvvisamente a bordo”.
Certamente fenomeni quali la guerra di corsa (senza trascurare il contrabbando e la cosiddetta dissimulazione’) non possono far altro che intensificare i rischi di contagio grazie alla continua frequentazione di porti ‘poco sicuri’; più che di pericolo di ‘contaminazione’ religiosa, che tanto apparentemente sembra preoccupare le varie potenze, si dovrebbe parlare piuttosto di pericolo di ‘contaminazione’ epidemica.
E la contrapposizione tra i due fronti, cristiano e islamico, va rammentato, non fu sempre netta, ma inquinata da interferenze che con la religione avevano poco da spartire e investivano semmai reciproci rapporti di potere.
La ricerca di alleanze trasversali dall’una e dall’altra parte è un dato di fatto ampiamente documentato.
Proprio perché quella contrapposizione non fu essenzialmente religiosa, ma politica e militare.
I nemici degli uni di volta in volta potevano essere gli amici degli altri, in un quadro di alleanze in cui si presentano diversi elementi di fluidità.
Insediati nei porti del nord-Africa, nominalmente soggetti al sultano ottomano ma via via sempre più autonomi (sino a sfiorare alla fine del Settecento quasi l’indipendenza di fatto) i barbareschi conducono per i tre secoli dell’età moderna una efficace guerra di corsa, con attacchi sistematici alle navi cristiane e con rapidi e micidiali sbarchi sulle coste; ad Algeri, Tunisi e Tripoli affluiscono così merci e uomini in grande quantità: sul recupero delle mercanzie predate e sul riscatto degli schiavi prospera un attivo commercio che coinvolge, ovviamente, molti uomini d’affari cristiani.
Bottino della pirateria e della corsa sono le merci ma anche, in molti casi soprattutto, gli uomini; la cattura di schiavi, destinati al riscatto, alla voga forzata nelle galere o al lavoro servile, alimenta uno dei più lucrosi giri d’affari nel Mediterraneo dell’età moderna.
In verità però all’attività corsara dei musulmani si oppose quella delle squadre delle marine cristiane ed anche di singoli privati corsari.
Quali corsari cristiani bisogna anzitutto riconoscere i due ordini cavallereschi e marinari dei Cavalieri di Malta e dei Cavalieri di Santo Stefano. La corsa, sia cristiana sia barbaresca, fu una grande occasione di rimescolamento d’uomini, così come fu un potente motore di interessi economici (S. Bono, 2006).
Nel 1768 la peste regna a Tripoli. Tripoli pratica, come Tunisi ed Algeri, la guerra di corsa: le Reggenze barbaresche vengono particolarmente temute non solo per i contrasti armati, ma anche per i possibili contagi.
La presenza numerosa e concentrata di schiavi nelle capitali barbaresche costituisce “una sorta di brodo di coltura della più ampia gamma di agenti patogeni”.
Il pericolo derivante dall’esposizione al contagio a causa della circolazione poco controllata di uomini e merci porta: “Dès la fin du XIVe siècle, différents ports européens de la Méditerranée, Venise, Marseille, Raguse, ont cherché à organiser une défense contre la peste, mais ce n’est qu’au XVIIe siècle que sont apparues des administrations sanitaires permanentes dotées de lieux d’observation isolés, les lazarets, et d’une réglementation spécifique”.
Struttura portante della lotta alle epidemie è il lazzaretto: “Les premières mesures de protection, les lazarets, les billets et patentes de santé sont apparus dans les villes méditerrannéennes d'abord, dans les cités de l'intérieur de l'Europe ensuite”.
Per nulla inconsueti sono gli ospiti illustri di tali strutture che si vedono più o meno costretti a permanere per un certo numero di giorni in condizioni non sempre agevoli, i quali danno però vita anche a ricordi quasi ‘divertenti’ dei loro soggiorni.
Del lazzaretto di Genova è ospite Jean-Jacques Rousseau nel 1743, a causa della peste di Messina, e come racconta ne Les confessions: “prima di tutto mi divertii a dar la caccia alle pulci che m’ero buscate nella feluca”.
Secondo il dottore francese, Antoine Clot Bey, naturalizzatosi egiziano con Muhammad Ali, non tutti i contagi dei più importanti porti euromediterranei si possono far risalire “à des violations de quarantaines, des fraudes, de contrabande”.
Ma in molti casi, tra cui quello messinese, il comportamento fraudolento di alcuni naviganti s’accoppia con atti di contrabbando a terra e con una certa dissimulazione di chi era incaricato di salvaguardare la salute pubblica.
Nei travagli della peste, quando però i medici avevano esaurito i loro (in verità pochi e soprattutto primitivi) espedienti, quando amuleti ed erbe prodigiose non sortivano alcun effetto, era il caso di rivolgersi ai santi protettori.
Cappelle, chiese, statue, “ex voto” venivano comunemente realizzati per la cessazione di un’epidemia di peste; soprattutto vi era un proliferare di pitture votive raffiguranti San Sebastiano, tradizionalmente invocato, insieme a San Rocco, in quanto santi contra pestem per eccellenza.
Il viaggiatore francese Pierre-Augustin Guys, divenuto console a Zante, riferisce le credenze popolari esistenti nel 1783 a proposito della peste: essa viene rappresentata come un terribile flagello che imperversa in Grecia, una vecchia donna vestita di nero che soffia durante la notte, sulle case che essa percorre, il veleno mortale che essa esala.
Anche a Corfù gli abitanti non trovano di meglio che affidarsi al protettore celeste della città: San Spiridion. “Nella tradizione locale ci sono quattro processioni annuali in onore del santo: due di queste sono direttamente connesse proprio alla liberazione dell’isola dal flagello di peste”.
Processioni, più o meno solenni, vengono organizzate (e pericolosamente gestite in quanto ideale focolaio di ulteriore contagio), scrive Restifo:
“Il corteo religioso, in particolare, percorre l’itinerario delle vecchie mura della città, per sottolineare come il santo quasi le avesse usate per respingere il morbo nemico (mentre a nulla erano servite le fortezze veneziane di fronte agli attacchi dei microbi)”.
Superstizione e razionalità, contrabbando e illegalità sembrano camminare di pari passo e talora confondersi.
A proposito di superstizione: Malta non ne è esente.
O meglio, il pregiudizio inglese nei confronti della cattolicissima isola ne provoca l’ultimo episodio di peste.
Malta, in ambito mediterraneo, appare infatti essere un interessante campo d’osservazione a riguardo delle politiche sanitarie.
L’arcipelago maltese si ritrova al centro del contesto della cosiddetta “unificazione microbica del Mediterraneo”.
“Si la mer était source de richesse, qu’elle liait Malte au continent, porteuse de lettres et de nouvelles, Malte étant le rendez-vous général de tous les vaisseaux du Ponant et du Levant » selon un voyageur anonyme du XVIIe siècle, elle était aussi porteuse de contagion, au moins pouvait-elle l’être. Malte servait, au XVIIIe siècle, «de dépôt de marchandises entre l’Orient et l’Occident» pour toute la Méditerranée, et ce, sans compter ses propres importations qui étaient nombreuses et ses quelques exportations” (C. De Pasquale, 2009).
La storia politica dell'isola la definisce, al termine della transizione dai Cavalieri agli Inglesi, come una “colonia” britannica, soggetta quindi agli esperimenti che la ‘potenza d’Albione’ conduce nel Mediterraneo, non solo sotto il profilo istituzionale.
C'è infatti una prova di doppia colonizzazione: quella del corpo collettivo maltese, ma anche quella dei corpi individuali.
Il tentativo inglese in ogni caso deve fare i conti con la resistenza maltese all’afflato colonizzatore: anche in questo caso vanno intrecciati i due piani - politico e sanitario - per avere una sufficiente ricognizione dello sviluppo delle cose.
Certo è che dopo secoli di una rigida politica sanitaria gerosolimitana, nel 1813 Malta si trova a dover nuovamente fronteggiare l’incubo peste a causa della dissennata politica britannica.
L'indirizzo è chiaro: smontare tutto ciò che ha parvenza d'autonomia locale, istituzioni sanitarie comprese.
Anche a Malta, un considerevole numero di ex-voto era stato dettato dall’incubo dalla peste del 1813-14.
Essi descrivevano vari aspetti medico-sociali della malattia.
Oltre a riflettere le allora correnti credenze religiose della comunità,costituiscono una testimonianza pittorica, e quindi visiva, delle misure adottate per salvaguardarsi dal contagio e sono di conseguenza documenti storici di grande significato.
Uno di questi ex-voto è un dipinto votivo su legno, attualmente collocato nella sacrestia della Chiesa di S. Barbara di Valletta.
Questa chiesa era la sede della Corporazione dei Bombardieri al tempo dell’Ordine.
Durante l’epidemia le chiese e i negozi di Valletta erano chiusi per ordine delle autorità sanitarie.
Le strade erano deserte e gli abitanti erano confinati nelle loro case.
Un diarista del tempo scrisse che “un cordoglio ed una malinconia generali avvolgevano l’intera città” di Valletta.
Il pittore dell’ex-voto riuscì a rappresentare questo senso di malinconia e di oppressione attraverso il marcato contrasto tra le vivaci attività mostrate in primo piano e la rappresentazione della desolazione dell’ospedale degli appestati vigilato dalle sentinelle, i carretti della morte che avanzano a mezza distanza e i bastioni deserti della città fortificata e le sue case con le porte e le finestre chiuse sullo sfondo.
Di certo le politiche sanitarie dei paesi euromediterranei vengono ostacolate da retaggi culturali che incentivano comportamenti e attitudini ‘discutibili’.
Come ricorda Paolo Preto la sensibilità etica e sanitaria degli uffici di sanità stranieri che dovrebbero collaborare nella reciproca informazione, trova un limite invalicabile nella cosiddetta “ragion di stato” che consiglia di minimizzare o addirittura di negare sospetti o realtà di epidemia, forieri di bandi, blocchi commerciali e quindi di rilevanti danni economici e politici; la stessa Venezia, quando si profila nel suo territorio un’epidemia, nicchia o procrastina sino all’ultimo la notizia ufficiale agli altri governi perché teme i blocchi commerciali o le aggressioni turche (P. Preto, 2010).
Per tali ragioni i provveditori alla sanità decidono in alcune occasioni l’invio di “esploratori di peste” incaricati di raccogliere notizie sicure in loco.
Per quanto terribile fosse il terrore della peste non va sminuito il terrore delle misure da prendere o a cui essere sottoposti.
Malgrado i controlli più o meno leciti, o più o meno ‘ufficiali’, come viene evidenziato da Restifo, “tuttavia egualmente da Split e dagli altri porti, ma anche dagli approdi minori, può venire un pericolo per l’intero Adriatico [e non solo]: il contagio da contrabbando”.
La vendita fatta di sotterfugio di merci che avrebbero dovuto essere esposte a quarantena provoca notevoli rischi.
Nel lazzaretto spalatino, ad esempio, giungono merci con carovane provenienti dal territorio turco, dove non viene effettuato alcun controllo sanitario.
Nel 1820, a causa di uno sbarco di contrabbando alla baia di Artà si introdusse un’epidemia di peste bubbonica.
A Mallorca in generale, e nella Comarca de Llevant in particolare, si erano attraversati due anni di crisi ed il contrabbando fu una delle attività economiche alternative che aveva consentito alle classi povere di sopravvivere.
L’attenta analisi dei casi di peste scoppiati tra Sette e Ottocento nel Mediterraneo centrale fa rilevare come “due movimenti contrastanti si pongono al termine del periodo preso in considerazione: unificazione microbica del Mediterraneo e opposizione politica tra le sue rive settentrionali e quelle meridionali.
La vecchia frontiera della peste viene sostituita dalla nuova frontiera di quel confronto fra Nord e Sud del mondo che costituisce una delle nostre contraddizioni epocali”.
Le conclusioni sono state ad opera dell'autore del volume che prendendo spunto da un noto motto di qualche anno fa e, nel contempo, dal titolo di uno dei capitoli della sua pubblicazione in argomento, ha trattato il tema "Reggio e Messina unite nella lotta".
Un motivo per quel titolo c’è - afferma il docente universitario Giuseppe Restifo - e non è solo il riecheggiare uno dei tanti slogan da corteo.
Le due città dello Stretto nel 1743 si trovarono ad affrontare la stessa sfida ambientale, lo stesso nemico: la peste.
Si era alla fine della seconda grande pandemia, quella cominciata proprio dallo Stretto nel 1347, destinata a diventare l’anno successivo la “Peste nera” con la sua scia di milioni di morti in Europa.
Nel 1743 si era alla fine del ciclo epidemico, ma la gente di Calabria e di Sicilia non lo sapeva; lo sappiamo noi oggi, perché ce lo dicono gli storici.
E poi solo ventitre anni prima del ‘43, nel 1720, c’era stata la grande epidemia di Marsiglia, con i suoi cinquantamila trapassi.
Come si faceva a stare tranquilli? Purtroppo però le due città di mare dello Stretto dovevano affrontare la “solita” contraddizione: aprirsi ai traffici marittimi per vivere, chiudersi ad essi per non morire.
Mano aperta e tesa per accogliere di tutto, in primo luogo il grano, quello che il loro hinterland non poteva fornire a sufficienza; mano chiusa a pugno per guardarsi dagli attacchi esterni, quelli militari, ma, ancora più subdoli e pericolosi, quelli epidemici.
Per guardarsi da questi, occorreva impiantare uffici di sanità, con i relativi “magistrati”,leggi sanitarie e regole, e poi il lazzaretto e i casini di sanità, con le navi alla fonda per quaranta giorni, in quarantena appunto.
Tutto questo armamentario rallentava il commercio, impantanava gli scambi, frenava l’economia.
D’altro canto quel sistema dava qualche speranza di sfuggire alla morsa del costante rischio del contagio, soprattutto in questo canale di passaggio fra l’Ovest e l’Est, in questo punto strategico per il transito verso l’Oriente.
L’Oriente nel ‘700 è ricco di merci, di mercanti, ma anche lussureggiante di rischi, dai corsari al bacillo della peste.
Lo Stretto non è barriera fra Est e Ovest, ma neanche fra Sicilia e Calabria.
E allora – anche se nel 1743 le due regioni appartengono a due regni diversi, seppure sotto lo stesso re – occorre lavorare «per la comune salvezza dal morbo contagioso», come recita un bel libro di Giovanni Assereto.
In effetti le due città furono percosse violentemente dall’ondata epidemica: a Messina morì il 70% della popolazione, a Reggio il 50.
Tutt’e due i centri furono contornati da cordoni sanitari, che non lasciavano passare le persone e neanche le merci: molti furono vittime della fame.
In ambedue le città si fece sentire la mano militare; per la verità più a Reggio che non a Messina, forse per la maggiore resistenza calabrese all’ordine costituito.
In entrambe si passò per lo “spurgo” per poter riprendere i contatti con il mondo esterno, che le aveva isolate e “sdegnate”.
La prospettiva di ricerca su quel doloroso momento vissuto dagli abitanti dello Stretto adesso è quella di superare il descrittivismo e la drammatica narrazione, che si sono snodati dalla fase successiva alla peste fino ai nostri giorni.
Le domande non mancano, a partire da quelle riguardanti la “vita” dei microparassiti nell’area e le condizioni climatiche e ambientali entro cui essa si svolgeva.
Degli uomini e di come tentarono di difendersi sappiamo già non tutto, ma abbastanza.
Forse è giunto il momento di porsi nuovi quesiti sul rapporto fra quegli uomini e gli ecosistemi
dentro cui vivevano, per chiedersi anche quali percezioni ne avessero e quale capacità previsionale riuscissero a mettere in campo.
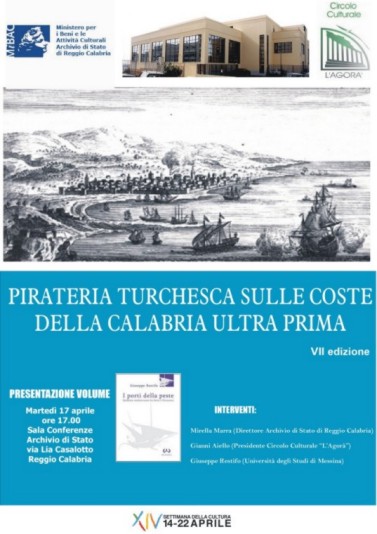
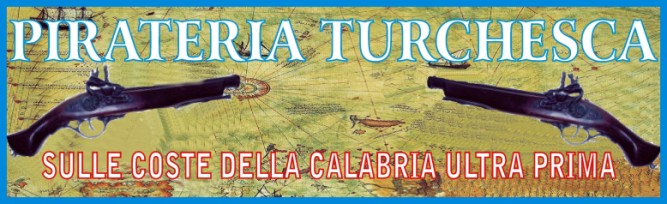


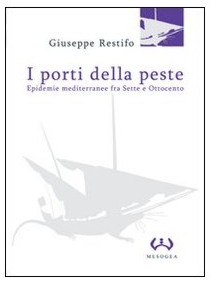
(1) Giusi Currò, Giuseppe Restifo, Reggio Calabria, Laterza, 1991;
(2) ASRC, Notai del distretto di Reggio Calabria, notar francesco rijtano, protocollo anno 1656, inventario 81, busta 428, volume 2296.