


Il “Mare Nostrum” è stato, da sempre, un contenitore di diverse culture e popolazioni che con i loro continui spostamenti hanno interessato una vasta area che va dalla penisola Iberica al Medio Oriente.
Tali movimenti hanno creato una sorta di polveriera etnica che è sfociata in intensi scambi commerciali e culturali, intervallati da guerre, che hanno favorito una contaminazione ed un arricchimento reciproco.
Sin dai tempi remoti si ebbero importanti movimenti di popoli nomadi che da est giunsero nel bacino del Mediterraneo, dove avevano trovato ubicazione dori e romani che rappresentavano la nuova linfa vitale di quel territorio che aveva visto le gesta degli antichi popoli mediterranei quali cretesi, calcidesi, etruschi, sardi, liguri, sanniti, dauni, fenici, tanto per fare qualche labile cenno di alcune delle molteplici e diverse etnie.
Tali impulsi migratori hanno dato vita ad un continuo movimento di diverse realtà si sono mescolate in un continuo succedersi di eventi sociali, culturali, amministrativi, politici, economici, religiosi, che hanno dato nuova linfa vitale al territorio.
Il Mediterraneo assume i tratti somatici del giusto crocevia delle grandi direttrici storiche dovute agli impulsi migratori derivanti non solo dalla ricerca di nuove terre ma anche da pressioni strategiche o politiche, razziali, spesso religiose che tali popoli migratori hanno subito nelle terre d’origine.
I movimenti di poli migratori nel bacino del Mediterraneo hanno avuto sempre una continuità ciclica a partire dai primi insediamenti indoeuropei, poi con le popolazioni italiote, i greci, i romani, e, successivamente quando quest’ultimi raggiunsero l’ensemble allo zenith della civilizzazione ebbero a scontrarsi ed a confrontarsi con una nuova ondata che proveniva sia dal Nord che dall’Est europeo.
L’incontro culturale che si è svolto presso la Sala Convegni del Museo Nazionale della Magna Grecia con l’Alto Patronato dell’Ambasciata della Repubblica d’Ungheria ha avuto il merito, grazie al contributo scientifico dei relatori di documentare i rapporti storico-culturali intercorsi pure tra il Sud, la Calabria e le popolazioni magiare e slave nel periodo medievale.
I magiari sono una popolazione di origine ugro-finnica, di stanza nell'Europa danubiana, formatasi dalla fusione di tribù turche con tribù irano-caucasiche; nel VII e VIII secolo, si spostò verso occidente per stabilirsi in Pannonia (Ungheria) e iniziare una serie di spedizioni verso i paesi occidentali.
Le incursioni dei magiari colpirono, in particolar modo, la vicina Germania, ma essi arrivarono anche in Francia ed in Italia, fino alla metà del X secolo.
Il “Mare Nostrum” è un bacino che bagna tre continenti: Europa, Africa ed Asia, dunque la sua ricchezza e la varietà dei contributi culturali dati dalle diverse popolazioni che si sono succedute in tale bacino di mare e nella fattispecie nella fascia meridionale sono straordinarie e su questi elementi scorre il percorso culturale e di ricerca del sodalizio reggino.
La manifestazione culturale è stata preceduta di alcune settimane dalla visita di una delegazione del Circolo Culturale L’Agorà a Roma, presso l’Ambasciata della Repubblica dì Ungheria, dove tali Autorità istituzionali hanno manifestato un vivo compiacimento per l’iniziativa convegnistica promossa dal sodalizio reggino.
Nella mattinata che ha preceduto il convegno reggino il prof. Pèter Kovàcs, Vice Direttore dell'Accademia d'Ungheria, nonchè rappresentante ufficiale dell'Ambasciatore Ungherese, è stato accompagnato da alcuni componenti del Circolo Culturale L'Agorà, in un giro di visite istituzionali in città che ha avuto come prima tappa l'Archivio di Stato.
Questa prima visita è stata caratterizzata, oltre che da un'accoglienza molto cordiale da parte dell'attuale direttrice dott.ssa Baldissarro e da tutto il suo staff, anche dalla possibilità concessa agli ospiti di visionare alcuni preziosi documenti del periodo angioino, tra i quali un privilegio dato alla città di Reggio il 16 giugno del 1383 dal Re di Napoli Carlo III d'Angiò-Durazzo, che sarebbe divenuto, per un breve periodo, anche re d'Ungheria.
Carlo aveva infatti sposato Margherita, nipote di Giovanna I, regina di Napoli ma, nel contempo, essendo stato adottato da Luigi I d'Ungheria, morto nell'agosto del 1384, si recò a Buda per acquisire il trono magiaro l'anno successivo.
Venne però assassinato in un complotto presso il castello di Visegrad il 24 febbraio 1386.
Ritornando alle visite istituzionali, la delegazione del sodalizio reggino ha fatto quindi una sosta presso la prestigiosa Biblioteca Comunale della nostra città, laddove l'attuale Direttore dott. Domenico Romeo ha entusiasticamente accompagnato l'Accademico ungherese nella visita ai locali dell'originale Biblioteca, che era l'abitazione dell'Ing. Pietro De Nava, poi acquistata dal Comune di Reggio Calabria.
Nelle eleganti stanze di tale edificio, decorate ed arredate secondo il gusto dei primi decenni del secolo, il prof. Peter Kovacs ha potuto ammirare le varie collezioni di volumi presenti, tra cui quella di Corrado Alvaro, ed anche una preziosa ed antica edizione illustrata della Divina Commedia.
Nei più recenti ed attigui locali della Biblioteca De Nava, il dott. Romeo ha anche illustrato all'importante ospite il plastico ricostruttivo della Reggio Calabria del seicento e, tra l'altro, una pregevole raccolta di stemmi di casate regnanti tra i quali quello di Carlo V d'Asburgo di particolare valore e bellezza.
L'itinerario di visita è poi proseguito in direzione di Palazzo San Giorgio, sede istituzionale del Comune di Reggio Calabria, dove il prof. Kovacs, come rappresentante dell'Ambasciata Ungherese, e la delegazione de L'Agorà, accolti dai Vigili Urbani in alta uniforme, sono stati ricevuti calorosamente dall'attuale vice sindaco dott. Giovanni Rizzica.
Il Vice Sindaco si è intrattenuto con gli ospiti in un affabile colloquio, congratulandosi con gli organizzatori per la pregevole manifestazione convegnistica ed auspicando, insieme al Diplomatico ungherese, un proseguimento delle iniziative di collaborazione culturale tra Reggio Calabria e l'Accademia ed ambasciata magiare, anche in considerazione del sempre crescente numero di ungheresi, lavoratori e studenti, che vivono nella nostra città.
Il prof. Kovacs ha ammirato con interesse le caratteristiche stilistiche del Palazzo cittadino, opera dell'Architetto E. Basile, visitandone anche l'elegante Aula Consiliare e ricevendo anche in questa sede istituzionale l'omaggio di alcune pubblicazioni culturali.
La stessa impronta di cordiale accoglienza ha caratterizzato l'ultima tappa del giro di visite istituzionali del prof. Kovacs, quella presso la sede centrale del palazzo "Pietro Foti" dell'Amministrazione Provinciale.
Il professore magiaro, dopo essersi soffermato ad ammirare l'Aula Consiliare ed altri pregevoli ambienti del Palazzo recentemente restaurato, è stato ricevuto, insieme ai membri dell'associazione culturale, dal vice Presidente dell'Ente dott. Leone Manti, dal dott. Francesco Crifò e Demetrio Cugliandro, nella preziosa cornice del salone Monsignor "Giovanni Ferro".
Il Vice Presidente ha espresso parole di plauso per l'iniziativa culturale intrapresa con la speranza che essa, al di là dell'alta valenza storico-convegnistica, possa rappresentare il preludio di nuove occasioni d'interscambio italo-ungherese di più ampio respiro, ed assicurando in tal senso la massima disponibilità e collaborazione da parte dell'Ente.
Il percorso del prof. Kovacs attraverso le varie sedi istituzionali cittadine è stato ovviamente intervallato dalla visita alle principali attrazioni turistico-culturali della nostra città, nei limiti del breve tempo disponibile, con una graditissima passeggiata sul lungomare del "più bel chilometro d'Italia" con visita alle Mura Greche ed alle Terme Romane, al Castello Aragonese, al Teatro Cilea, al Duomo e naturalmente ai tesori custoditi nel Museo Nazionale della Magna Grecia.
I lavori sono stati coordinati dal segretario dell'associazione, Natale Bova, il quale ha premesso che il Circolo Culturale L’Agorà è promotore, ormai da diversi anni, di numerosi convegni che hanno trattato argomenti di storia della Calabria e del Meridione, e che hanno l’obiettivo di contribuire a valorizzare il bagaglio culturale, a volte di portata straordinaria, lasciato dai vari popoli che hanno attraversato il nostro territorio nel corso dei secoli.
Tra questi i greco-bizantini, gli arabi, gli armeni, i normanno-svevi, gli angioini, gli aragonesi, gli spagnoli, gli austriaci, i francesi.
Il segretario ha avuto anche il merito di assemblare il susseguirsi delle relazioni che hanno illustrato ai presenti gli intrecci tra la dinastia degli Angioini del Regno di Napoli e la dinastia del Regno d'Ungheria, fino all'invasione nel 1300, da parte degli Ungheresi, del meridione della penisola.
Il periodo in questione è quello compreso soprattutto tra il nono ed il quattordicesimo secolo e le vicende storiche trattate sono degne di approfondimento, anche per aver lasciato a Napoli, nel Sud, ed anche in Calabria, alcune chiare testimonianze, sia sul piano artistico-architettonico che della nomastica e toponomastica, sebbene in tono minore rispetto ad altri popoli ed amministrazioni straniere.
Il prof. Giuseppe Caridi, docente presso l'Università di Messina, ha relazionato su "La Calabria nel periodo Angioino" delineando in un rapido excursus la tipologia delle varie dominazioni succedutesi in Calabria dal X al XV secolo, da bizantini, longobardi ed arabi ai normanno-svevi e quindi agli angioini e agli aragonesi.
Il relatore si è soffermato principalmente sul periodo della Calabria angioina durante il quale si svolse l'invasione ungherese del Regno di Napoli della metà del '300, oggetto del convegno. Carlo d'Angiò si era insediato nel Mezzogiorno dopo la sconfitta di Manfredi nel 1266 ed aveva trasferito la capitale da Palermo a Napoli.
Questo fu uno dei motivi di malcontento dei siciliani che insorsero nel 1282 e con l'arrivo in Sicilia degli aragonesi fu solo il Meridione continentale (Regno di Sicilia Citra) a rimanere sotto la corona angioina.
La nostra Regione che rimase divisa amministrativamente , come al tempo degli svevi, nelle due circoscrizioni territoriali di Val di Crati e Terra Giordana (Cosentino, Crotonese, parte del Catanzarese) e Giustizierato di Calabria (parte meridionale della regione), attraversò una fase particolarmente critica dalla morte di Roberto d'Angiò (1343) all'avvento di Alfonso V d'Aragona (1442).
Si tratta del periodo delle lotte tra le due fazioni degli Angioini di Durazzo e di Provenza e la situazione diventò ancor più drammatica, a metà del XIV secolo, oltre che per le vicende belliche e le invasioni ungheresi, anche per lo scoppio della famigerata peste nera, un'ecatombe che ridusse la popolazione europea di 25 milioni di unità sugli 80 del totale, e vide la scomparsa di ben 148 agglomerati urbani nella sola Calabria, con le inevitabili ripercussioni anche sul piano economico e produttivo.
Si è passati quindi, con la relazione di Daniele Castrizio dell’Università di Messina, alla trattazione di fatti prettamente militari.
La sua relazione su "L'utilizzo di contingenti slavi nell'Italia bizantina", ha trattato degli equipaggiamenti e delle tattiche usate dai contingenti militari di stanza nella parte meridionale della penisola.
L'intervento del Castrizio si è aperto con una premessa di tipo storico-numismatico, risalente ad un periodo ventennale di lotta tra Durazzeschi e Provenzali, e cioè la notizia che ci fu un periodo in cui a Reggio e in Calabria, come in Ungheria, circolarono le stesse monete: si tratta dei tornesi angioini presenti in Calabria fino al 1328, poi spariti e quindi riportati in Italia dopo il 1350 dalle milizie ungheresi che nel frattempo li avevano utilizzati nel loro Paese.
In questa seconda fase tali monete vennero anche nuovamente coniate da zecche italiane (es. Ancona) ad imitazione di quelle usate dai soldati magiari.
Il relatore è quindi passato alla trattazione dell'utilizzo dei contingenti slavi da parte dell'esercito bizantino per la difesa dello stretto di Messina, dopo la caduta della Sicilia in mano ai Musulmani i quali perseguivano sempre il progetto di giungere fino a Roma.
E' stato precisato che le notizie su questo argomento sono ancora esigue ma meriterebbero un approfondimento, perché poco studiate e perchè fatti toccati marginalmente dalla storiografia, vista anche l'abitudine bizantina di non scoprire i rapporti internazionali della città di Reggio e dello Stretto.
A questo proposito il relatore ha auspicato che la storia bizantina venga riscritta, rivedendo il luogo comune di quelle "vulgate" che parlano del periodo bizantino come fatto solo di tasse e di rivolte.
Le milizie slave sono state dunque sicuramente presenti in Calabria dal IX al XI secolo come sappiamo da alcune fonti storiche, sigilli, pezzi di ceramica, ed erano reclutate particolarmente nei temi (province) dei Balcani.
Si trattava di mercenari a buon mercato, ottimi soldati pronti a difendere la loro causa fino alla morte, che furono utilizzati per contenere gli Arabi fino alla metà del X secolo.
I bizantini erano svantaggiati nei confronti degli arabi, sia da un punto di vista numerico che nella disponibilità al sacrificio umano: i manuali strategici bizantini dicevano che era meglio perdere una battaglia che un soldato. Reggio riuscì quindi a fermare i saraceni in almeno 7-8 tentativi di assalto nell'arco di circa 200 anni, grazie ad un sistema di difesa "elastico" consentito dalla presenza di una fortezza sulla collina del Trabocchetto, che consentiva la fuga dei reggini verso le alture a ogni notizia di arrivo degli arabi.
Non si trattava però di una fuga ignominiosa ma strategica, perché alle spalle della città era stato costruito un sistema di fortezze, Montebello, Motta S.Giovanni, Motta S.Niceto, Motta S.Agata, Motta S.Cirillo, Motta Anomeri, Motta Rossa e Motta Calanna, e dietro ad esse una seconda linea di difesa aspromontana, che permettevano ai Reggini di intraprendere un periodo di guerriglia con i musulmani fino a quando questi non avessero smobilitato.
Visto che le forze di invasione arabe non potevano mantenersi "senza bottino", venivano ritirate ed il contingente arabo lasciato in loco veniva sconfitto dal ritorno dell'esercito tematico bizantino, che poteva così riappropriarsi del territorio.
Le milizie slave verranno utilizzate dai romei anche dopo la metà del X secolo nel tentativo dell'Imperatore bizantino Basilio II di riconquistare la Sicilia, caduta in mano agli Arabi.
Tale impresa ebbe come pretesto la vendetta per l'uccisione dell'emiro di Siracusa , alleato dei Bizantini e nominato Maestro di Palazzo, da parte del fratello.
A capo di questo esercito venne posto Giorgio Maniace che con la vittoriosa battaglia di Troina, grazie anche alle milizie super-specializzate di una leggendaria "drucina" russa, ebbe spalancate le porte della Sicilia, ma dovette interrompere la sua impresa perché richiamato a corte dall'imperatore.
Alla partenza di Maniace i Normanni iniziarono l'occupazione della Puglia, depredata in maniera funesta dal milanese Arduino, ed il generale che subentrò a Maniace, che tra l'altro donò un mantello alla Chiesa reggina di S.Nicolò di Calamizzi, venne inviato a contrastarli.
Ma gli imperiali verranno cacciati dal meridione nel giro di circa 10 anni.
Il relatore ha anche illustrato al pubblico presente, con l'ausilio di alcune diapositive, le ricostruzioni di soldati slavi del X secolo, con la cotta in maglia, i rinforzi di cuoio ed un'armatura leggera con protezioni metalliche agli avambracci, la spada , lo scudo tondo, la lunga lancia.
Ma poiché i soldati più efficienti erano quelli a cavallo era stata fatta una riforma che assegnava un appezzamento di terreno con cui il milite poteva mantenersi le armi e il cavallo.
Tutto sommato l'esercito "tematico" non era economicamente costoso e, poichè combatteva anche per la propria famiglia, aveva buone motivazioni per non disertare.
Circa 100 anni dopo le armature riportarono solo poche innovazioni. Sono state proiettate anche immagini delle milizie della drucina russa che inizialmente partecipanti all'assedio di Costantinopoli, raffigurato in una diapositiva, vennero poi integrate nell'esercito bizantino diventandone la punta di diamante.
I russi possedevano gli elmi decorati con figure di angeli e santi e portavano il volto coperto da una maschera. In un'altra ricostruzione, fatta da professori greci, i guerrieri russi della drucina vengono raffigurati come portatori di asce, armi da combattimento di derivazione vichinga.
Altre diapositive proiettate hanno infine raffigurato un arciere bulgaro e scene belliche come lo sbarco delle navi bizantine sulla spiaggia di Messina con gli arabi morenti o imprigionati.
L'assetto amministrativo del regno angioino è stato trattato dal prof. Mario Spizziri dell’Università degli Studi di Cosenza, che nel corso della sua relazione “Organizzazione centrale e periferica nel Regno di Napoli” ha evidenziato il progresso avvenuto sul territorio, seppure lento, ma che ha portato dei miglioramenti, sia dal punto di vista sociale che amministrativo.
Re Ruggero il Normanno (XII secolo) organizzando i suoi possedimenti dell’Italia meridionale e insulare creò ben 7 grandi dignitari e/o ufficiali di quella che - da lì a breve- sarebbe stata la novella monarchia con speciali e ben
definite attribuzioni.
Essi erano: il Contestabile, il Grande Ammiraglio, il Gran Cancelliere, il Gran Giustiziere, il Gran Camerario, il Gran Protonotario, il Gran Siniscalco.
Un breve ma efficace riordinamento venne operato dal suo successore, il re Guglielmo I, detto il Malo, che rese stabile e non più provvisoria, quasi per intero, la compagine e, con particolare riferimento, la Gran Corte di Giustizia alla quale era preposto, ab origine, il Gran Cancelliere con l’assistenza pratico-tecnica del Gran Giustiziere.
La Gran Corte di Giustizia assunse, quindi e in forma ormai irreversibile, la funzione di Supremo Tribunale a cui facevano capo le Udienze Provinciali presiedute, queste ultime, da Giustizieri ai quali si riferivano, gerarchicamente, i tribunali minori e/o locali, presieduti da particolari figure di funzionari: i baiuli.
In epoca sveva e/o federiciana, dal grande e illuminato sovrano non vennero affatto mutati gli ordinamenti amministrativi precedenti ma si tenne anzi a dichiarare in alcune Costituzioni che quella organizzazione statuale andava rispettata e consolidata e con una serie di saggi e opportuni provvedimenti.
Ai Giustizieri e/o autorità provinciali, dipendenti dalla Gran Corte di Giustizia, ormai stabilmente presieduta dal Gran Giustiziere, in particolare, fu commessa la somma dei poteri del mero imperio tranne che per le questioni concernenti i grandi feudi.
Si impose loro, comunque, che essi ispezionassero le province di loro competenza col molteplice scopo di rendere più agevole l’amministrazione della giustizia, di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento degli organismi inferiori (baiuli e capitani).
Il tutto rimase immutato anche all’avvento e per buona parte del regno di Carlo I d’Angiò.
Ma nel 1283, allorché il sovrano angioino dovette lasciare Napoli per raggiungere Bordeaux per quel famoso, strano duello con Pietro d’Aragona, in conseguenza dei fatti del Vespri e per il definitivo possesso della Sicilia, nella capitale venne insediata, in supplenza della Gran Corte, la Corte del Vicario, ossia del figlio primogenito del Re, anch’esso denominato Carlo, principe di Salerno, l’organismo venne subitamente definito Corte della Vicaria.
Allorché, poi, Carlo, principe di Salerno, salì al trono come Carlo II, re di Napoli, quella Corte di supplenza venne istituzionalizzata e divenne esecutiva.
Negli intenti vi era il desiderio di fondere in uno i due supremi organismi ma ciò, come era già allora in tutte le cose italiche, non avvenne ed entrambe continuarono a funzionare separatamente per tutta l’epoca angioina.
La Corte del Vicario, ormai non più presieduta dall’erede al trono, fu, però, posta sotto la presidenza del Gran Giustiziere.
Intanto si era, sempre di più, venuta a razionalizzarsi la vasta gamma delle competenze del Giustiziere, capo dell’Udienza e/o vero e proprio Tribunale di provincia.
Questi aveva giurisdizione in materia civile e penale ma non poteva ancora intervenire in alcuni ambiti di diritto feudale ossia nelle vertenze tra feudatari (soprattutto di gran rilievo), demandate direttamente al supremo organismo di Giustizia.
In ogni provincia, inoltre, in materia fiscale vigilava l’ufficio del Camerario che, in ambito locale, si serviva anch’esso dell’opera dei baiuli o baglivi. Il baiulo aveva competenza minima per le cause civili e penali, preparava una rudimentale istruzione dei processi e inviava gli imputati al “suo” Giustiziere.
Quale reperto occasionale vorrei segnalare, inoltre , che, durante i 176 anni di permanenza degli Angioini nel regno di Napoli, il foro napoletano fu ingrandito ed onorato e i magistrati vennero elevati a dignità di casta.
All’avvento, poi, degli Aragonesi, re Alfonso volle fondare una “sua” Corte Suprema che potesse giudicare ogni materia civile, criminale e amministrativa e la definì “Sacro Regio Consiglio”.
Il presidente del Circolo Culturale L’Agorà Gianni Aiello ha trattato il tema relativo a “Gli Ungari dagli Urali allo Stretto” descrivendo diversi aspetti relativi a tale periodo storico, passando da quelli toponomastici, nomastici, architettonici a quelli agiografici, «elementi questi - ha precisato il relatore - utili a ricomporre un mosaico di memoria storica che ci appartiene».
Nell' 898, i primi nuclei di Magiari provenienti dalle regioni del basso Danubio arrivarono in Italia, invadendo il territorio lagunare.Vengono fatti quindi chiari riferimenti a pubblicazioni di un certo rilievo scientifico, come quella dello storico francese Jacques Le Goff «…L’invasione magiara si svolge secondo il solito schema. Nel VII secolo gli Ungari si stabiliscono nello stato dei Kazari, turchi convertiti al giudaismo e stabiliti nel basso Volga, dove controllano un commercio molto prospero fra la Scandinavia, la Russia e il mondo musulmano. Ma verso la fine del IX secolo altri Turchi, i Peceneghi, distruggono l’impero kazaro e spingono verso est gli Ungari. Questi ricordano agli Occidentali gli Unni. La stessa vita a cavallo, la stessa superiorità militare di arcieri. L’avanzata incomincia a partire dall’899 : Friuli, Veneto, la Lombardia, la Baviera, la Svevia… sono tra le prime aree interessate». (1)
Nel 921 tornarono ancora in Italia, devastarono nel 924 Pavia e più tardi piccoli nuclei di cavalieri magiari erano presenti nell’hinterland di Capua e di Benevento, nonché parecchie contrade dell’Italia meridionale, fino alle Puglie.
Nel 1105 si verificò un primo legame dinastico tra l'Ungheria ed il meridione d'Italia con le nozze del re magiaro Calomanno (1095 – 1116) con Busilla, figlia di Ruggiero I Altavilla di Sicilia.
Viene quindi trattata l'arrivo degli ungheri in Calabria nell'alto medioevo, allorquando una milizia magiara era giunta nella nostra regione, utilizzata dagli eserciti bizantini contro i Longobardi.
A questo evento alcuni Autori fanno risalire il casale Ungarum o Longrium che sarebbe poi diventato, secondo questa ipotesi, l'odierno abitato di Lungro (CS) che esisteva già dal 1268.
Va però anche evidenziato che, secondo un'altra ipotesi, l'origine del nome Lungro deriva dal nome greco ügros = umido che venne dato a questa zona.
Ma un altro elemento che rafforza l'ipotesi dell'origine ungherese di Lungro è il ritrovamento di un teschio di guerriero ungherese in quella zona.
Il relatore è quindi passato a narrare le vicende storiche relative agli angioini di
Napoli e di Ungheria nel corso del XIV secolo. La complessa vicenda della successione dinastica al trono di Napoli inizia a causa della premorienza al padre Re Roberto d'Angiò dell'erede Carlo l'Illustre, Duca di Calabria, nel 1328 e della volontà dello stesso sovrano di favorire la successione della nipote Giovanna, ostacolata dalle vigenti regole di successione che le pretese al trono di Napoli del nipote Caroberto, già Re d'Ungheria. La questione era stata risolta grazie alla celebrazione del matrimonio tra Giovanna ed Andrea, figlio di Caroberto.
Di tali nozze parla il seguente documento del Regesto Vaticano datato 3 Novembre 1333 in cui si legge:«Carolo, Regi Hungarie conceditur dispensatio de matrimonio contrahendo inter Andream, secundum genitum eius, et Iohannam, primo genitam [Caroli] Calabriae, seu Mariam, eius sonorem, casu quo Iohanna decederet.- Dat. Avinione, III Non. Novembris, Anno Decimoctavo»
Il Re d’Ungheria era venuto a Napoli ad assistere allo sposalizio del figliuolo, e quando se ne partì gli lasciò per familiari alcuni suoi ungheri, “ed un tale frà Roberto di che lo ammaestrasse di lettere e di buona creanza.” (3)
Il frate calabrese viene menzionato nel 1333, dopo il matrimonio tra Giovanna I e Andrea d'Ungheria, entrambi di appena sette anni, celebrato il 26 settembre 1333.
Roberto divenne vescovo di Tropea (1344-1348) sarà un personaggio chiave della successiva vicenda dell'invasione ungherese del regno di Napoli che si verificherà dopo l'assassinio di Andrea d'Ungheria avvenuto ad Aversa il 18 settembre 1345 ad opera di una congiura a cui parteciparono tra gli altri il nobile calabrese Caraffello Caraffa e due giovani di nobile famiglia tropeana, Raimondo e Tommaso Pace, che accusati di partecipazione all'assassinio di Andrea, furono torturati a morte, sebbene tutti gli storici siano stati concordi nel ritenerli innocenti; anche il Boccaccio ne fa allusione in "Filippa di Catania".
Successivamente al regicidio, la vedova Giovanna I, temendo la vendetta del cognato Ludovico e nel tentativo di farsi scagionare dall'accusa di partecipazione all'assassinio del marito, mandò lo stesso vescovo di Tropea in Ungheria, in qualità di ambasciatore, ma tale missione era destinata a fallire.
Il 1° maggio del 1346 Luigi d' Ungheria spedì ambasciatori al Pontefice chiedendo che Giovanna fosse deposta, che il figlio Carlo fosse affidato alle cure della nonna paterna Elisabetta e infine che durante la minorità dell'erede il reame fosse governato da un consiglio di reggenza.
Non soddisfatto della risposta di Clemente VI, Luigi armò un esercito, con il quale doveva imbarcasi a Zara, ma questa città ancora una volta si era ribellata ai Veneziani e si trovava allora bloccata da una flotta della repubblica.
Rimandò quindi la spedizione e impiegò parte dell'anno seguente a procurarsi libero passaggio attraverso l'Italia con una serie di azioni diplomatiche con i vari Stati che avrebbe dovuto attraversare con l'esercito.
Il 3 novembre del 1347 il re d' Ungheria si mosse da Buda, proprio quando la regina Giovanna il 20 agosto si sposò in seconde nozze con il cugino Luigi di Taranto. L'11 gennaio del 1348 giunse a Benevento, alla testa di seimila cavalieri, che erano comandati dal duca Guarnieri d' Urslingen e qui il relatore fa un riferimento alla nomastica: infatti il cognome Uslenghi, oggi presente sul territorio, è una derivazione di tale cognome, così come altri cognomi hanno derivazione ungherese, es. Buda, Berta (collocato proprio nella zona di Cataforio (RC) nel territorio di Motta S.Agata, Ungaro, Zungri, Ungheri.
Nello stesso territorio di Motta S.Agata vi era una guarnigione magiara, infatti il territorio di Sant’Agata era sotto l'amministrazione magiara e “… durante questo tormentato periodo Sant’Agata fu «una delle poche piazzeforti che occupata una volta dagli ungheresi non valeva a liberarsene neppure a guerra finita.» …” (4)
E qui il relatore lancia due ipotesi: o che i santagatini ritenevano non più conveniente sostenere la causa di Giovanna I, oppure l'idea più romantica di sostenere pienamente le ragioni del sovrano Luigi d'Ungheria.
Il re magiaro, intanto proseguì il suo percorso e da Benevento si diresse verso Napoli dove ricevette l'omaggio di diversi notabili del tempo tra i quali Carlo di Durazzo, cognato di Giovanna I, ma prima di entrare nella capitalevolle visitare il Convento del Murrone, dove era stato assassinato il fratello Andrea.
Ma qui inveì contro Carlo di Durazzo, che venne colpito a morte da un milite ungherese e, successivamente fatto precipitare da quella stessa finestra dalla quale era stato gettato Andrea.
La presenza di Ludovico d'Ungheria nel Regno di Napoli durò appena quattro mesi, in quanto sul territorio scoppiò la peste nera, ed a seguito di ciò il sovrano tornò in Ungheria, lasciando diverse milizie nel Regno di Napoli.
Ma nonostante ciò i contatti tra la Calabria e l'Ungheria continuano, infatti nel 1349 si hanno notizie di un certo Filippo Misbano, comandante degli Ungheresi che inflisse una dura sconfitta all'esercito della regina Giovanna, comandato dal Conte di Chiaromonte "... in questi luoghi della Calabria..." (5) .
Mentre nel 1352, alla conclusione della pace tra Giovanna I e Ludovico d'Ungheria appare la figura di Andrea di Ruggero, nobile di Tropea e "milites", personaggio che nel Medioevo indicava quel rango sociale.
Altri elementi di lettura della relazione di Gianni Aiello sono quelli relativi alla descrizione araldica di uno stemma gentilizio, probabilmente dello stesso Andrea di Ruggero, ma soprattutto di un altro stemma che raffigura "l'arme, sostenuta da angeli ed uno scudo recante le insegne dell'Ungheria antica, costituite da quattro barre orizzontali privedella croce patriarcale o di Lorena, ed appartiene a Maria d'Ungheria, figlia di Stefano V, re d'Ungheria, e moglie di Carlo II lo Zoppo"(6).
Per quanto riguarda il tema agiografico, il relatore fa un riferimento alla figura di San Ladislao re d'Ungheria, venerato anche nel Meridione d'Italia, durante l'amministrazione angioina e di cui una pala che lo raffigura è ubicata presso la chiesa di S.Maria della Consolazione di Altomonte (CS).
Gianni Aiello ha concluso il suo intervento conuna famosa citazione del sovrano magiaro Stefano I :«Gli ospiti che vengono dai vari paesi portano lingue, usanze, strumenti, armi diverse e tutte queste diversità è per il regno un ornamento, per la corte un abbellimento e per i nemici esterni un oggetto di timore. Poiché un Regno che ha una lingua sola e un solo costume è debole e fragile».
L'intervento di Antonio Stiriti, socio del Circolo Culturale, è stato incentrato sulla "Genealogia degli angioni di Napoli e di Ungheria", con l'obiettivo di contribuire ad inquadrare, in una cornice cronologico-grafica, i protagonisti delle vicende napoletano-ungheresi del '300 descritte nella precedente relazione.
In Ungheria si era stabilita, sin dal X secolo, la dinastia regnante degli ARPAD, dal nome del suo capostipite, a cui seguirono i principi Zolta, Falicsi, Tacsony e Geza che convertì il suo popolo al cristianesimo.
Stefano il Santo fu il primo re a ricevere la corona dal Papato, da allora in poi detta Corona di Santo Stefano, ed a lui seguirono Pietro Orseolo, Samuele Aba, Pietro, Andrea I, Bela I e Ladislao I, anch'egli canonizzato.
Il successore Calomanno (1095-1116) sposò la figlia del normanno Ruggero I di Sicilia (primo contatto dinastico tra l'Ungheria ed il meridione d'Italia) mentre i successivi re Stefano II, Bela II, Geza II, Stefano III con gli zii usurpatori Ladislao II e Stefano IV, Bela II, Emerico e Andrea II ingrandirono notevolmente lo stato e lo assestarono dal punto di vista politico e amministrativo.
Si giunse quindi al regno di Bela IV durante il quale avvenne l'invasione dei Tartari (1241), punta avanzata in Occidente del grande impero asiatico, ma tale invasione si ridimensionò fortunatamente per motivi interni.
L'Ungheria capì comunque di dovere trovare alleati in Occidente e quindi accogliere la politica matrimoniale degli Angioini, che corrispondeva anche alla precisa volontà della Santa Sede di consolidare una grande potenza cristiana nel cuore dell'Europa danubiana.
Carlo d'Angiò , dopo la sconfitta degli Svevi, si presentava come uno dei principi più valorosi d'Europa e, avendo ereditato il titolo nominale di Imperatore latino d'Oriente (1261) e acquisito quello di Re di Gerusalemme (1277), era desideroso di espandersi verso oriente accarezzando il sogno di ricostituire l'Impero Romano.
Rifiutata la richiesta matrimoniale (1269) di Carlo d'Angiò per Margherita Arpad, la figlia di Bela IV che preferì restare religiosa domenicana, le nozze si celebrarono tra l'erede Carlo II d'Angiò e la principessa arpadiana Maria, figlia di Stefano V, successore di Bela IV.
A Stefano V successe il figlio Ladislao alla cui morte si estinse la discendenza maschile della dinastia Arpad ma il trono, subito rivendicato dalla Regina di Napoli Maria arpadiana a favore del figlio Carlo Martello, andò invece ad un ultimo discendente illegittimo della dinastia Arpad, Andrea III il Veneziano che regnò per undici anni.
Successivamente la nobiltà ungherese elesse prima Venceslao di Boemia, genero di Andrea III, e quindi il duca Ottone di Baviera. Nel frattempo, premorto al padre l'angioino Carlo Martello(1295), fu suo figlio Caroberto, anche grazie all'appoggio della Santa Sede, che riuscì a cingere la corona d'Ungheria nell'ottobre del 1307.
Figli di Caroberto furono Luigi il Grande, che gli successe al trono d'Ungheria, ed il fratello Andrea che sposò l'erede al trono di Napoli Giovanna d'Angiò e che verrà presto assassinato suscitando l'invasione del Regno di Napoli, che giunse a lambire anche la nostra provincia, per vendetta del fratello Luigi.
Tale matrimonio era stato voluto per acquietare le pretese dinastiche dei regnanti ungheresi sul trono di Napoli, visto che essendo premorto al padre Carlo l'Illustre, il Re di Napoli Roberto d'Angiò volle favorire l'ascesa al trono della nipote Giovanna che come discendente femminile era ostacolata dalle regole di successione sancite dal Patto di Vassallaggio al Papato di Carlo d'Angiò (1264) e dalla successiva Bolla Papale di Bonifacio VIII (1297).
Sul trono d'Ungheria, infine, alla morte di Luigi il Grande dopo 40 anni di regno, successe per tre anni la figlia Maria sotto la tutela della Regina vedova ma il suo trono fu poi usurpato nel 1385 dal re di Napoli Carlo III di Durazzo, che era stato adottato da Luigi il Grande e molto amato dai nobili ungheresi.
Carlo III, re di Napoli e d'Ungheria, regnò però pochi mesi perché fu assassinato a Buda, in una congiura di Palazzo.
L'intervento di Antonio Stiriti, apprezzato dal pubblico presente in sala, si è arricchito della proiezione di ritratti o sculture dei regnanti protagonisti delle vicende narrate.
Il prof Pèter Kovàcs,Vice Direttore dell’Accademia d’Ungheria e delegato dell’Ambasciata Ungherese, nelle sue conclusioni ha espresso viva soddisfazione per quanto è stato messo in luce sui diversi punti di contatto storici tra l'Ungheria e la Calabria, due aree geografiche lontane per alcuni aspetti ma ben vicine per altri.
Ha inoltre manifestato il chiaro desiderio di proseguire questo percorso culturale ringraziando nello specifico i componenti del sodalizio reggino che hanno avuto il merito di trattare questo tipo di argomenti.
Lo stesso auspicio ha espresso la Sovrintendente ai Beni Archeologici della Calabria Annalisa Zarattini che, oltre a porgere il Suo saluto, si è complimentata per il lavoro svolto dal Circolo Culturale L’Agorà.




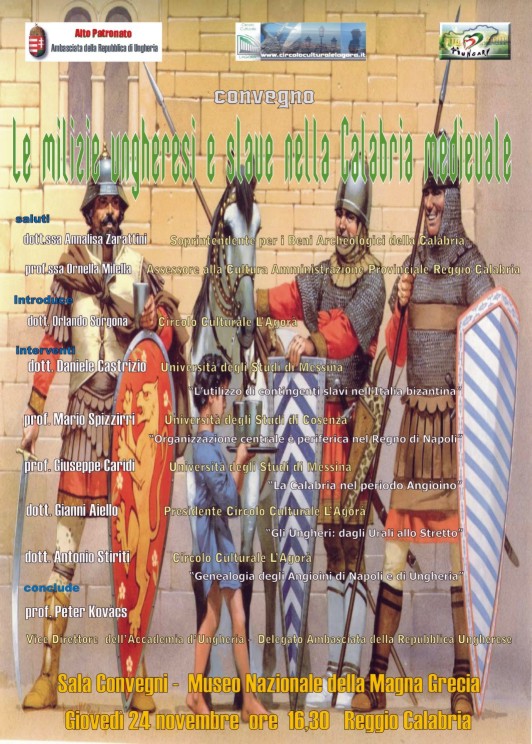
(1) Jacques Le Goff “La civilta’ dell’occidente medievale”, Einaudi
(2) padre Francesco Russo "Regesto Vaticano"
(3) Spanò-Bolani "Storia di Reggio Calabria"
(4) Giannangelo Spagnolio "De Rebus Rheginis"
(5) Antonio De Salvo "Palmi, Seminara e Gioia Tauro"
(6) Antonio Vizzone "i casati di tropea"