

La giornata di studi organizzata dal sodalizio reggino prende spunto dai dati emersi nel corso della giornata di lunedì 3 maggio 2010, momento che ha caratterizzato la nuova denominazione alla Via Apollo, intitolata ora a Gennaro Musella vittima della ‘ndrangheta.
Come evidenziato nei comunicati stampa, successivi alla manifestazione sopra menzionata, il Circolo Culturale “L’Agorà” è favorevole con quanto espresso con gli intervenuti alla manifestazione dello scorso 3 maggio nella quale si precisava da più parti “la lotta a tutte le mafie”, così come chi affermava che “la memoria è qualcosa che va custodita e trasmessa ai giovani perché possa divenire storia”.
Nello specifico e cioè ai termini di “memoria”, “custodia”, “giovani generazioni”, “storia”, il sodalizio reggino ha inteso organizzare l’incontro per capire ed informare i cittadini presenti all’incontro a riguardo tali decisioni.
La toponomastica non può e non deve rappresentare soltanto un pezzo di marmo dove è inciso un nome o una località che ne indica una via, una piazza: essa rappresenta la memoria storica del territorio in cui essa è ubicata.
Da queste premesse le cifre della manifestazione organizzata dal sodalizio reggino, sempre attento e sensibile alle varie problematiche culturali che interessano il territorio come ha evidenziato nel corso del suo intervento il segretario del Circolo Culturale “L’Agorà” che ha ricordato ai presenti alcune operazioni in tal senso come l’adozione dei resti archeologici della Chiesa normanna dell'XI
secolo, denominata di "San Giovanni" e la petizione popolare indirizzata allo spostamento della statua dell’onorevole Biagio Camagna da piazza Castello al suo sito naturale, nella fattispecie la piazza omonima.
Ritornando alla manifestazione c'è da evidenziare che essa ha posto gli accenti su alcune scelte da parte di Palazzo San Giorgio nei confronti di alcune nuove denominazioni toponomastiche cittadine come ad esempio quella di Via Apollo, ufficializzata in quella data con la nuova denominazione di “Gennaro Musella vittima della ‘ndrangheta”.
Ciò è conseguenza del tragico evento avvenuto proprio in Via Apollo al centro di Reggio Calabria in quel mattino del 3 maggio 1982 quando a seguito di un attentato dinamitardo rimase dilaniato dall'esplosione della sua autovettura l'ingegnere salernitano.
Ma altri fatti di tale portata si sono verificati con la stessa violenza e brutalità come ad esempio quelli accaduti a Roma in data 16 marzo 1978 in via Mario Fani che coinvolse la scorta dell'onorevole Aldo Moro (Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi).
Altro caso quello relativo all'attentato di stampo mafioso nei confronti del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta (Manuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cusina, Claudio Traina ed Agostino Catalano) avvenuto in via D'Amelio il 19 luglio 1992 a Palermo.
I tragici eventi di Roma e Palermo hanno la stessa tragicità di ciò che avvenne in via Apollo, eppure la toponomastica di via Mario Fani (Roma) e quella di via D'Amelio (Palermo) hanno conservato la stessa denominazione, cosa, invece, non avvenuta a Reggio Calabria.
A tal proposito c'è da registrare che nonostante il parere negativo dal parte della Commissione toponomastica del Comune di Reggio Calabria c'è stato il cambio della denominazione da Via Apollo a Via Gennaro Musella, come tra l'altro ha evidenziato nel corso del suo intervento di Francesco Arillotta componente della stessa Commissione.
La prima parte del dibattimento è stata diretta da Natale Bova, segretario del Circolo Culturale “L'Agorà” che partendo dall'etimologia della parola toponomastica e dei suoi significati ha aggiunto che per quanto riguarda Reggio Calabria essa ci giunge deformata nel tempo, in quanto la città nel corso dei secoli ha assunto varie denominazioni.
A tal proposito ha evidenziato che alcuni toponimi resistono a tutt'oggi.
La toponomastica reggina è fortemente legata ai due grandi momenti della storia urbanistica della città: l'assetto datole dagli ingegneri dopo il terremoto del 1783 e quello adottato dopo il terremoto del 1908.
Della città classica, ellenistica e romana, restano dei riferimenti alcuni visibili altri tramandati dagli storici ma nessuno di essi ci dà dei toponimi.
Alcuni studiosi ritengono la riorganizzazione dell'impianto cittadino medievale sia avvenuto al tempo dei Normanni.
Sempre nel medioevo la città non aveva una toponomastica come la intendiamo oggi e bisogna arrivare al XV secolo per avere coscienza dei toponimi reggini.
In tale contesto storico si identificavano le “terre” dell'Università (il territorio comunale) , ossia “ il tenimento” con i vari “casali” e “contrade”, questo fuori città.
Nell'ambito urbano invece si usavano i seguenti: “regione”, “convicinio”, “piazza o platea”, le “porte” , le “mura”, le chiese, edifici di carattere pubblico, le aggregazioni artigianali (quali i “bottari”, “forgiari”, “calzolari”); si citano pure le “contrade”.
Il termine “quartiere” si usava per indicare quasi esclusivamente la zona militare dentro la cinta muraria.
Il relatore ha effettuato un excursus storico su tali denominazioni come “Porta Amalfitana”, “Porta Terzana”, “Porta della Dogana o della Marina”, “Porta Mesa”, “Porta Crisafi”. “Porta del trabucco”, il “Toccogrande”, il “Toccopiccolo”, il “Piano S. Astasi”, la “fiera d'agosto”, la “Giudecca” (quartiere ebraico), la “regione Mesa”, la “battagliola”, la “mezza porta”, la “meschita”
(moschea), “ospedale maggiore” o di “S.Margherita” o di “S.Gregorio”, tanto per citare qualche esempio.
A questi luoghi segue una carrellata di denominazioni più circostanziate quali “torre di Maugeri”, “forte S.Francesco”, il “castello”, il “Castelnuovo”.
La zona settentrionale di Reggio Calabria nel periodo in questione era in continua trasformazione con nuove architetture che si sovrapponevano ad un tessuto minuto composto da case e da una costellazione di piccole chiese.
La città medievale finì di essere tale a seguito dei terremoti del 1783 che la fece classificare in parte distrutta ed in parte danneggiata.
Il maresciallo Francesco Pignatelli venne nominato con Regio Decreto per la ricostruzione della città che subì molti fermi a causa di molti processi e ricorsi alle autorità.
Fu anche eletta una Deputazione cittadina composta da quattro membri per collaborare con i tecnici.
Il progetto Pignatelli era impostato su maglie regolari lungo l'asse rettilineo che da Porta S. Filippo conduceva al Tempio di S.Paolo fuori la “Mesa”.
Il cosiddetto “stradone” tagliava la città come la vecchia “via maestra” che però era stretto e tortuoso.
Esso fu poi denominato “Murat” sotto l'amministrazione francese, “corso Borbonio” conla successiva amministrazione, della “Vittoria” con Garibaldi per assumere l'attuale denominazione di “corso Garibaldi”.
Con la nomina dell'ingegnere Giovanbattista Mori si avviò un'altra fase indirizzata all'abbattimento delle vecchie strutture architettoniche come le porte e le mura.
La città venne divisa in rioni che a loro volta comprendevano più isole (isolati), ai quali i francesi diedero denominazione.
Come dicevamo infatti i lavori andavano a rilento e si sbloccarono con la spinta propulsiva dei napoleonidi.
Fu licenziata la “Deputazione cittadina” istituendo la “Giunta di riedificazione”.
Si intimò, settembre 1811, la demolizione dei ruderi e degli ostacoli entro il termine dei sei giorni.
Venne stabilito di lastricare lo “stradone” utilizzando la “pietra di Macellari” e le strade trasversali, la messa in loco dei riverberi (lampioni), disponendo le perizie per la “casa comunale” combinandola con il “teatro” , i pubblici acquedotti, il compimento della fontana ubicata nella zona della marina, il Liceo, i ponti sul Calopinace e sull'Annunziata ed ancora la denominazione delle strade e la numerazione delle porte.
È doverosa da parte nostra precisare – prosegue Natale Bova - che non tutto fu ultimato per le note vicende storiche che si susseguirono.
Agli inizi del XIX secolo, quindi, la nuova città cominciò a conoscere denominazioni più intenzionali che si ispiravano ancora ai vecchi criteri “convicinali”.
Troviamo inoltre i primi riferimenti al passato magno-greco ed intitolazioni in ricordo alle massime istituzioni amministrative reggine quali (Arconti, Zecca, Pritanei).
Nei primi anni '70 del secolo in questione si pose il problema di risanare i quartieri malsani della città quali quelli posti ad est ed a sud come le zone denominate “Fornace” e “S. Filippo”, “Pantano”.
Tale intervento cercò di riorganizzare l'ingresso della città a sud allungando il corso Garibaldi (la sua sistemazione e l'illuminazione attirò popolazione ed attività commerciale) dove insistevano l'attuale piazza Garibaldi e la stazione ferroviaria, l'orto botanico (villa comunale).
Si dilatò pure la città a settentrione oltre S. Lucia (l'attuale piazza De Nava) fissando il nuovo limite comprendente la borgata di S. Caterina.
Anche ad est sulle colline effettuarono altri interessamenti urbanistici.
Dopo millenni, il porto terminato nel 1888 fu trasferito presso l'attuale sito.
Alla fine del secolo si incrementarono i toponomi legati alla magnagrecia (Ibico, Poseidonea) e successivamente quelli relativi a (Pitagora, Apollo).
Il nuovo secolo, il '900, vede l'ufficializzazione della via Poseidonia (l'attuale Possidonia, trascrizione errata di Poseidonia) ma anche la denominazione di nuovi luoghi dovuti al disastro del terremoto del 1908.
Gli accampamenti di baracche erano vasti e frutto della grande solidarietà italiana e straniera.
Le opere di soccorso portarono a Reggio l'esercito con vari Reggimenti ed il “ventesimo Brescia” fu
destinato stanzialmente in città, ubicato in località “Borrace” ed ecco il toponimo “caserma Borrace”.
I baraccamenti avvennero nella zona nord tra i torrenti di S. Lucia e dell'Annunziata verso la zona denominata “Caserta”, e a S. Caterina; al centro, tra la via Tribunali (oggi Demetrio Tripepi) ed Aschenez, ed in tutte le adiacenze di via Reggio Campi.
A sud le baracche si espansero nelle zone denominate “Crocefisso”, “S. Anna”, “Spirito Santo”,” S. Giorgio extra”, “Sbarre”.
I villaggi di legno presero il nome dai Comitati donatori dei manufatti come ad esempio i villaggi “svizzero”, “norvegese”, il rione “Friuli”, “S. Marco”, “Napoli”, “Tedesco”, “Romano”, “Americano”, oppure dalle ditte dei terreni espropriati o dalle località dove erano ubicate come ad esempio rione “Scordo”, “Muro rotto”.
Per i baraccamenti militari anziché denominarli, furono assegnati le lettere dalla “A” alla “I”, alcuni di tali toponimi sono a tutt'oggi esistenti.
C'è da dire che la toponomastica dei baraccamenti durante questo periodo fu molto confusa come ad
esempio i casi di via Udine, ubicata in contesti separati (al di qua ed al di la del torrente S. Lucia) e del rione Friuli, che a seguito della sistemazione viaria cittadina, si ebbe lo spostamento della via Udine e Trieste in altro luogo; e la soppressione di altre strade come le vie denominate “Chioggia”, “Rovigo”, “Aquileia”, “Rovereto”.
Per quanto riguarda la denominazione delle vie cittadine troviamo interessanti quelle del baraccamento americano (“via New York” – attuale “via Libertà”, “viale Columbia” - attuale “via Monsignor De Lorenzo”, “via California” oggi via “Tito Minniti”, “via Tremulini I” oggi “via Ibico” ,“ via Tremuilini II” oggi “via Baracca”, la “via Rooswelt” oggi “via Salazar”.
A ricordo di detto rione rimangono le sole vie “Pensilvania” e “Georgia”.
Durante l'amministrazione fascista la città venne ricostruita.
A riguardo c'è da ricordare – prosegue il segretario del sodalizio organizzatore – sia gli edifici pubblici, quali enti, istituti bancari, l'edilizia popolare, le scuole, la stazione centrale, il lido comunale, lo stadio comunale “Michele Bianchi” oggi “Oreste Granillo”, “piazza del Popolo”, all'epoca denominata “XXXI marzo”, Museo della Magna Grecia e l'aeroporto.
La toponomastica di allora ci ricorda altre denominazioni oggi non più esistenti come quelle di “via Stringhe Bonaldo” (prolungamento di via Palamolla lato mare), “Via Lazio” (via Bruno Buozzi ultimo tratto lato sud), “via Maggiore” (tra l'attuale villa Comunale e piazza S.Agostino), “via Milazzo” (nei pressi dei mercati generali), “via Milano “ (via Placido Geraci), “via Mussolini” (via XXV luglio), “via Castelnuovo” (tra via Tommasini e via XXI agosto), “via Palermo” (via Saccà), “via Napoli” (nei pressi dell'attuale via Saccà), “via Torino” (tra via Firenze e via Venezia) , “rione conventino”)parte dell'attuale zona del Trabocchetto in prossimità del convento di S. Domenico sulla via Reggio Campi).
In tale periodo si aggiunsero altre vie la cui denominazione ricordava il periodo della magna grecia (Glauco, Clearco, Zaleuco, Locri, Cauonia, Magna Grecia, Esperia, Enotria ed Ibico – nuova denominazione).
Contemporaneamente si intitolarono la romanità le vie (Apollo, Diana, Giulia, Dei Correttori, Archia Poeta, Zenodoro).
Negli ultimi decenni del novecento abbiamo le intitolazioni nella zona sud di Reggio come quelle relative a (viale Calabria, viale Europa, viale Aldo Moro, via Sibari, via Ipponio).
Altre vie recanti soltanto la numerazione (traversa I, II, IV) attendono ancora una denominazione ed a tal proposito la Commissione Toponomastica – continua Natale Bova – ha pronti circa mille toponimi da inserire nella toponomastica ufficiale.
Dopo l'esauriente excursus storico di Natale Bova, la parola è passata a Francesco Arillotta (Commissione Comunale Toponomastica, Deputazione di Storia Patria Calabria) il quale ha portato i saluti del dott. Giuseppe Tuccio (Presidente Commissione Comunale Toponomastica), del Prof. Giuseppe Caridi (Presidente Deputazione di Storia Patria Calabria) entrambi assenti: il primo per problemi di salute, il secondo per sopraggiunti motivi istituzionali.
Il relatore nel corso del suo intervento ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa del Circolo Culturale “L’Agorà”, in quanto la stessa risulta un’operazione culturale coraggiosa, nata da una situazione piuttosto complicata difficile, che si è creata in Città proprio a proposito di toponomastica e per la quale c'è sempre una sensibilità da parte dei reggini.
Evidenziando anche che a riguardo la toponomastica c'è una procedura da seguire: la consulta propone, la giunta delibera, il consiglio approva o meno, poi il parere della Prefettura, poi la Sovrintendenza tutta questo iter non è stato osservato
La stessa legge dice che ci sono dei casi eccezionali, dietro decreto particolare da parte della Prefettura, stranezze che sono state effettuate sia sotto l'amministrazione Falcomatà e la stessa situazione si è verificata sotto l'amministrazione Scopelliti: vedi la situazione ed il cambiamento delle denominazioni sia sua Via marina alta che quella bassa.
Da queste doverose premesse lo storico Arillotta è passato poi a tracciare l’operato della Commissione Comunale Toponomastica di Reggio Calabria negli ultimi periodi di attività e nello specifico del lavoro svolto da quella precedente.
La Consulta era diretta dal giudice Marino e della quale facevano parte il prof. Falcomatà, il dott. Romeo, la dott.ssa Mariotti, il prof. Ferrara e tanti altri nomi illustri della cultura reggina e questo lavoro aveva avuto due principi base.
Il primo era quello di fare le denominazioni per aree, cioè tutti quei toponomi che fanno parte di un determinato periodo storico ubicati in un'area della Città ben precisa
Quindi il periodo magno-greco in una determinata zona, quello relativo alla fondazione
Questo lavoro aveva avuto due principi di base:il primo era quello di fare le denominazioni per aree , cioè indirizzare il territorio in base ad un periodo storico determinato della città, mentre l'altro principio era quello che la toponomastica del centro storico non doveva subire delle variazioni.
Ma strada facendo – prosegue Arillotta – sono avvenute altre cose .
Ritornano al lavoro svolto c'è una realtà - spiega Francesco Arillotta - che deriva da una massa di toponimi che la Consulta ha verificato nel corso degli ultimi anni completando il lavoro nel 2007 e riguardanti il territorio comunale da Catona a Pellaro e tra l'altro era stato fatto un lavoro con le Circoscrizioni che hanno dato il loro contributo indicando i nomi legati a quello specifico territorio.
Di seguito sono state tracciate le aree e suddivise per periodi storici, come ad esempio quelli romani, bizantino (zona Reggio Campi) , fino a giungere a periodi più moderni come ad esempio la zona di Santa Caterina con toponimi relativi ai caduti, quindi le medaglie d'oro del primo conflitto mondiale.
Nel corso della giornata di studi sono state evidenziate anche alcune “caratteristiche” della toponomastica cittadina, come ad esempio la strada che và da piazza Vittorio Emanuele II e Piazzetta Genovese ha tre nomi un nome per ogni due isolati: via Miraglia, via Dei Bianchi , via Fratelli Plutino.
Da queste situazioni sia era deciso – continua Arillotta di dare una denominazione unica per via Dei Bianchi proprio per la sua importanza storica e soprattutto all'importanza ed al significato che la Congrega dei Bianchi ha rappresentato.
Altri esempi riguardano la via XXI agosto la parte alta di mantenere tale denominazione, mentre la restante bassa con la denominazione via Fratelli Plutino
Mentre altre modifiche conclude Francesco Arillotta sono state apportate senza il parere della Consulta per le nuove denominazioni e nello specifico quelle relative a Musella (via Apollo) e l'altra all'avvocato Valenzise (via Crisafi) ricadente nel centro storico.
A conclusione è seguito un appassionato dibattito con il pubblico presente alla giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” che ha evidenziato il suo rammarico per il cambio di alcune denominazioni stradali, tra cui quella di via Apollo, il mancato coinvolgimento in tali scelte, la costituzione di un Comitato indirizzato a sollecitare il Comune di Reggio Calabria a buon operare e ad intervenire presso chi di competenza (organi prefettizi e Ministero degli Interni) per risolvere l'iter burocratico in riferimento al lavoro compiuto dalla Consulta per una rapida attuazione.
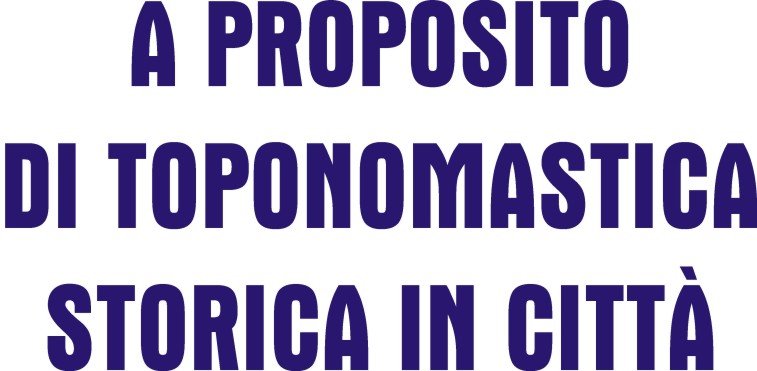


LEGGE 24 DICEMBRE 1954 N. 1228 (LEGGE ANAGRAFICA):
Art. 10, 1° comma - Il comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
LEGGE 23 GIUGNO 1927 N. 1188
1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della Regione.
2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
3. ( omissis)
4. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa nazionale. E' inoltre facoltà del Ministero per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato dalla nazione.
5 e 6. (omissis)
R.D.L. 10 MAGGIO 1923 N. 1158 CONVERTITO IN LEGGE 17 APRILE 1925 N. 473 - NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI
Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.