

Secondo appuntamento dei “Pomeriggi Culturali”, sempre nella cornice della villetta della Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria, questa volta si tratta di un approfondimento di una grande personalità della cultura italiana, nella rubrica intitolata “Uomini contro”, e, nello specifico la figura di Pier Paolo Pasolini, tratteggiando per ovvi motivi “logistici”, quindi di tempo, visto la sua poliedrica figura culturale di poeta, scrittore di romanzi e di teatro, regista, pittore, gli aspetti relativi al Pasolini giornalista ed il momento della morte.
Nella sua breve introduzione Gianni Aiello ha voluto significare il termine della rubrica “Uomini contro” e cioè «coloro che hanno il coraggio della diversità, coloro che vanno avanti, proseguendo il loro percorso anche contro quando si è consapevoli di stravolgere le regole, “Uomini contro”, anche nel tentativo di frantumare il silenzio. Uomini contro anche “in direzione ostinata e contraria” come ebbe a dire Fabrizio De Andrè».
Lo stesso cantautore, insieme a Massimo Bubola, prese spunto dalla morte di Pier Paolo Pasolini per la canzone “Una storia sbagliata” registrata nel 1980 ed incisa per l’etichetta discografica “Ricordi” .
La stessa canzone recita “[…] Una spiaggia ai piedi del letto stazione Termini ai piedi del cuore è una notte un po' concitata una notte sbagliata [...]”, la stessa, come ebbe a rilasciare il cantautore genovese fu una canzone che gli venne commissionata come sigla per alcuni documentari televisivi inerenti le morti dello stesso Pasolini e Wilma Montesi.
Ma in precedenza venne scritta, nel dicembre del 1975 “Lamento per la morte di Pasolini” , da Giovanna Marini nel dicembre del 1975 e successivamente ripresa nel 2003 da Francesco De Gregori nell’album “Il fischio del vapore” (2003) […Ma quella notte volevo parlare La pioggia il fango e l’auto per scappare Solo a morire lì vicino al mare Ma quella notte volevo parlare …] anche se lo stesso cantautore romano nel 1985, dieci anni dopo la morte di Pasolini, incideva “A Pa”, canzone facente parte dell’album “Scacchi e tarocchi” (RCA italiana) […C'era Roma così lontana E c'era Roma così vicina E c'era quella luce che ti chiama Come una stella mattutina…].
La parola è poi passata al relatore vero e proprio Antonino Megali.
«Ma chi è quel fijo de ‘na mignotta che ha scaricato la mondezza sotto casa mia? Me so detta appena l’ho visto: pareva un sacco di stracci. E invece era n’omo. Morto». Sono le 6,30 di domenica 2 novembre 1975 quando una casalinga, in gita con la famiglia, fa la macabra scoperta. Poche ore prima in quell’idroscalo di Ostia, dove erano state girate alcune scene del “Fiore delle mille e una notte” veniva ucciso da un ragazzo di diciassette anni, Pier Paolo Pasolini. Ha la testa fracassata, i capelli impastati di sangue,il volto sfigurato. Quell’uomo, scambiato per “un sacco di stracci” da poeta, romanziere, critico letterario, regista, giornalista, polemista, era stato un protagonista della vita culturale italiana, subendo dal 1949 al 1977 (quindi oltre la fine) ben trentatrè procedimenti giudiziari.
Ai suoi funerali Moravia, facendo uso di una retorica d’accatto- il giudizio è dell’editore Livio Garzanti- gridò: «È morto un poeta.
Di poeti così ne nascono due o tre ogni secolo». «È morto un poeta» ripeté Elsa Morante che aveva preferito non esserci sul palco degli oratori ufficiali e per la quale il termine aveva qualcosa di sacro tanto da considerarsi poeta (non poetessa!), lei che pure di versi ne aveva scritti ben poco.
Da ricordare che il primo, mentre si recava sul luogo del delitto, commentò rivolgendosi a Renzo Paris, con cinismo e sarcasmo: «Tanto và la gatta al lardo che ci lascia lo zampino».
Aggiungendo subito dopo: «Ma perché non ha fatto come Visconti? Che bisogna c’era di portarselo su un prato?».
La seconda aveva interrotto i rapporti con Pasolini quando seppe che Ninetto Davoli aveva dovuto chiedere il permesso allo scrittore per sposare la donna della quale era innamorato. Ma sulla morte torneremo in seguito.
Abbiamo privilegiato di parlare del giornalista per motivi evidenti.
Primo perché sarebbe impossibile accennare in così poco tempo all’intera produzione pasoliniana; secondo perché i romanzi sono illeggibili, tra le poesie poche sono quelle da salvare, i suoi films sentono tutti il peso degli anni, i testi teatrali irrapresentabili.
Ultimo, ma non ultimo, sono proprio gli scritti ulla politica e sulla società a coinvolgerci ancora.
Aggiungiamo però che non intendiamo fare ripartizioni sull’opera del nostro autore, perché i motivi conduttori sono sempre gli stessi, come fu precoce la sua vocazione di pedagogo e di capo e costante la rivendicazione del diritto di contraddirsi.
È del 1942 l’esordio giornalistico di Pasolini.
A Bologna diventa redattore capo de “Il Setaccio”, pubblicazione della Gioventù Italiana del Littorio, con vaghe tendenze frondiste nel campo culturale – chiusa dopo poco mesi – e ad “Architrave”, rivista del Gruppo Universitario Fascista.
Sulla prima di rilevante pubblicherà l’”Ultimo discorso degli intellettuali”, un atto di accusa contro la cultura manipolata dalla propaganda; sulla seconda un articolo intitolato “Cultura italiana e cultura europea a Weimar”, ispirato al suo viaggio nella Germania nazista dove si era svolto un incontro della Gioventù Universitaria dei paesi fascisti o filo fascisti (erano presenti, fra gli altri, anche Vittoriani e Giaime Pintor).
In esso dice di avere scoperto aspetti della cultura europea a lui sconosciuti: «i giovani europei con cui ho parlato mi hanno assicurato privatamente che nella vecchia Europa l’intelligenza, come la libertà, è ancora ben viva; così viva da non soltanto contrapporsi beffardamente e gagliardamente alla tradizione ufficiale degli organi propagandistici, ma da adeguarsi per conto proprio, al tempo e alla storia con un atto imprevedibile, ma ormai giustificato, di pacificazione o di liberazione».
Gli anni dell’immediato dopoguerra lo vedono collaborare al quotidiano udinese “Libertà” , dove fa la scelta politica della sua vita. «Noi, da parte nostra, siamo convinti che solo il Comunismo attualmente sia in grado di fornire una nuova cultura “vera”, una cultura che sia moralità, interpretazione intera dell’esistenza».
Ancora suoi interventi sulla scuola, sul Friuli, sulla democrazia, vengono pubblicati da “Il Mattino del Popolo”.
Nel 1949 la svolta. Accusato di indegnità politica per atti immorali compiuti verso quattro ragazzi, Pasolini viene espulso dal PCI.
Così recita lo scarno comunicato de “l’Unità”: «Prendiamo spunto dai fatti che hanno determinato un grave provvedimento disciplinare a carico del poeta Pasolini per denunciare ancora una volta le deleterie influenze di certe correnti ideologiche e filosofiche dei vari Gide, Sartre e di altrettanto decantati poeti e letterati, che si vogliono atteggiare a progressisti, ma che in realtà raccolgono i più deleteri aspetti della generazione borghese».
Espulso dal partito e poi dalla scuola lo scrittore parte con la madre, per Roma. Qui conosce lo scrittore Sandro Penna, si iscrive al Sindacato comparse di Cinecittà, fa il correttore di bozze, riesce perfino a farsi pubblicare qualche articolo sui quotidiani cattolici e di estrema destra: “Il Quotidiano”, “il Popolo di Roma”, “Libertà d’Italia”, vende i suoi libri sulle bancarelle.
Roma gli procura “stordimento” e “consolazione” la preferisce a Milano (come dirà rispondendo ad un’inchiesta di Adele Cambria) , «cittadina di provincia come Cremona, Mantova e Bergamo, col suo cattolicesimo dolorante, e la sua borghesia ben pensante per diritto in quanto non priva di tradizionale dignità. Roma non è mai stata moralmente e civicamente pura. Quindi non è corrotta».
Fu nella capitale che conobbe gli amici con i quali passò tutta la sua vita: Elsa Morante, Moravia, Parise, Bertolucci, Elsa De Giorgi; poi Siciliano, Laura Betti, Adriana Asti.
Alberto Moravia al suo primo incontro con Pier Paolo Pasolini lo descrisse come un tipo piccolino, con il naso rincagnato, che vuole scrivere un romanzo intitolato “Ferrobedò” (primo capitolo dei ragazzi di vita).
Seguendo il percorso giornalistico dobbiamo arrivare al 1955 per la nascita di una importante rivista: “Officina” uscì a Bologna e a dirigerla furono Leonetti, Roversi, e appunto Pasolini.
La pubblicazione “bimestrale” era insieme letteraria e politica.
Nel primo Pasolini si occupa di Pascoli definendo rivoluzionario il suo plurilinguismo.
Tra i collaboratori vi furono Gadda, Bertolucci, Volponi, Calvino.
Ma l’orientamento era quello del Partito Comunista Italiano, tanto che alcune poesie di Mario Luzzi furono ospitate solo per il diretto invito di Pasolini.
Altri suoi interventi interessarono la poesia, la saggistica letteraria, con una posizione un po’ frondista attaccando i cànoni del “realismo socialista” imposti allora da Salinari.
Nel 1959 un’attacco, feroce quanto gratuito, contro Pio XII ne accellerò la chiusura.
Ne citiamo i versi finali: «Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato/davanti ai tuoi occhi son vissuti in stabbi e porcili/lo sapevi, peccare non significa fare il male/non fare il bene questo significa peccare/.Quanto bene tu potevi fare! E non l’hai fatto/non c’è stato un peccatore più grande di te».
Nello stesso anno la polemica con il Sud per un articolo intitolato “la lunga strada di sabbia sulle spiagge italiane”.
Lo pubblica “Successo”, il mensile diretto da Arturo Tofanelli. Superficiale, banale, sommaria e la condanna del Sud.
«Addio, Sud, cafarnao sterminato alle mie spalle; brulichio di miseri, di ladri, di sensuali, pura e oscura riserva di vita».
E sulle donne: «Non voglio insinuare che nel Sud non ci siano belle donne: io, comunque, in centinaia e centinaia di chilometri di litorale non ne ho viste. Ho visto delle femminucce nere ed ineleganti, delle adolescenti gelatinose … poveri branchi di maschi del Sud;».
E sulla nostra Reggio sentenzia: «Reggio è una città estremamente drammatica e originale, di un’angosciosa povertà, dove sui camion che passano per le lunghe vie parallele al mare, si vedono scritte come “Dio aiutaci”».
Ma c’è n’è anche per Cutro: «A un distendersi di dune gialle, in una specie di altopiano è il luogo che più impressiona di tutto il viaggio. È veramente il paese dei banditi, come si vede in certi westerns. Ecco le donne dei banditi. Ecco i figli dei banditi.
Si sente che siamo fuori dalla legge, o, se non dalla legge, dalla cultura del nostro mondo, a un altro livello. Nel sorriso dei giovani che tornano al loro atroce lavoro, c’è un guizzo di troppa libertà, quasi di pazzia».
Infine, secondo lo scrittore, a Taranto le donne “fanno il bagno clandestino” ma poi sono piccoline piccoline, nere come vermetti ma anche un pò gonfie di anche, benché magari adolescenti, con gli occhi neri affumicati, misteriosi e insipidi”.
Naturalmente segue la querela del Sindaco di Cutro poi ritirata ed una del Comune con sentenza di non doversi procedere.
Ma è con la collaborazione a “Vie Nuove” settimanale del PCI che Pasolini comincia a diventare personaggio. Sporadiche collaborazioni c’erano già state sul settimanale,ma ora gli viene affidata una rubrica fissa “Dialogo con i lettori”.
La Macciocchi, che allora lo dirigeva, confessa, nelle sue memoria d’ignorare che fosse stato espulso dal PCI per indegnità morale.
Entrò in redazione, racconta, vestito con blu jeans stretti da un cinturone di cuoio con le borchie, la camicia aperta sul collo, l’aria un pò canagliesca, il tutto contrastante con la sua gentilezza e timidezza, con l’impaccio di un giovanotto ben educato.
Ignoravo che fosse omosessuale, lo appresi dai redattori che, quando se ne andava sghignazzavano “quel frocio”.Lo scrittore, considera”quasi come un dolce dovere una corrispondenza con i lettori.”E’ accetta. La posta viene prima filtrata dalla direttrice e poi passata alla risposta del curatore. Gli argomenti posti e i pareri richiesti sono i più disparati:un giudizio sulla letteratura ungherese, un consiglio sul battesimo di un figlio o su un fidanzamento, il problema del latino e qualcuno lo rimprovera perfino per le “parolacce” o le cose poco piacevoli dei suoi romanzi.
Pasolini risponde a tutti a modo suo :prolisso, retorico,burocratico,puntiglioso,alternando finto candore politico e furbizia intellettuale,paternalismo e populismo,fuga nel passato e pessimismo sul presente.
Finché non scoppiò la tempesta.Riportiamo nuovamente dalle memorie della Macciocchi:”non è possibile che la prosa di quell’omosessuale di Pasolini venga letta nelle case dei proletari,dalle loro famiglie! Proclamò un giorno del 1960, nel Comitato Centrale, Mario Montagnana, cognato di Togliatti. Allontanate questo pederasta da “Vie Nuove! ”Togliatti non sarebbe restato sordo all’invito dal momento che aveva nel 1950 attaccato duramente Gide per lo stesso motivo.Rifiutai- conclude la Macciocchi-di eliminare la rubrica dei Dialoghi e così la mia fine di direttore-direttrice- era stata sanzionata.
Pasolini non reagì e quando qualche anno dopo,il nuovo direttore Giorgio Cingoli gli chiese di riprendere la collaborazione,accettò senza esitare,spiegando ai lettori che la sua assenza era stata causata da una malattia. Negli anni seguenti aumenta il dissenso nei confronti del partito comunista e si esaurisce il rapporto con il settimanale.
Nel 1968, anno cruciale,lo scrittore entra al settimanale “Tempo” titolare della rubrica “il Caos”.
Qui diventa una firma, tanto che, non a caso presentandolo, viene messe in rilievo che in passato la pagina era stata affidata a Massimo Bontempelli, Curzio Malaparte, Salvatore Quasimodo, Giovanni Ansaldo.
Questa volta è Pasolini a scegliere i temi diventando eccezionali le lettere dei lettori.
Si parla di politica, di costume, appunti di viaggio, recensioni, festival di Sanremo, della tv, della droga.
Ma pur non avendo “Tempo” una precisa linea politica (ospitando giornalisti di diverso orientamento politico come Vittorio Gorresio e Enrico Mattei), mal si sopporta l’eccessiva personalizzazione dei suoi scritti, diventati ormai una palestra dalla quale in modo confuso alterna invito alla legalità e all’eversione, diventa progressista e estremista, è contro il terrorismo ma predica la violenza, uomo dello scandalo e moralista, difendendo sempre il diritto a contraddirsi dal momento che solo le contraddizioni permettono - a suo parere- l’affermazione della personalità.
D’altra parte incominciava a capire che la sua visione del mondo – quella del sottoproletariato urbano fedele a una cultura contadina –era superata e prendere atto che il consumismo aveva conquistato tutti, era stato per lui un grosso trauma politico e culturale.
Però egli pretendeva di rimanere fedele alla sua utopia, sia pure concepita come sogno irrealizzabile. Anche questa volta il rapporto con il giornale s’incrina.
Il direttore di “Tempo”, Nicola Cattedra, dopo avergli tagliato alcuni pezzi, gli scrive che i temi politici trattati non rientrano nella tematica del “Caos”.
La rubrica è sospesa. Due anni dopo Pasolini ritorna a collaborare al settimanale ma solo con scritti di critica letteraria che verranno raccolte nel volume postumo “Descrizioni di descrizioni”.
Ma quello che veramente permette a Pasolini di essere al centro dell’attenzione e di amplificare le sue polemiche è l’ingresso, nel 1973, al “Corriere della Sera”.
Come era arrivato al grande quotidiano della borghesia lombarda? Facciamo un passo indietro.
Nel 1972 viene defenestrato dalla direzione del “Corriere della Sera” Giovanni Spadolini, e sostituito da Piero Ottone, pseudonimo di Pier Leone Mignanego, convinto che bisognava dare al giornale un’impronta meno moderata, più stimolante e palestra di diverse e opposte opinione politiche. Nico Naldini, cugino di Pasolini per via materna, conosceva l’ambiente editoriale milanese.
Quando Gaspare Barbiellini Amidi, vice direttore del quotidiano meneghino gli fece sapere che il giornale avrebbe gradito la collaborazione di Pier Paolo, Naldini fece da tramite col cugino.
Accettata l’offerta di collaborazione il 7 gennaio 1973 esce il primo articolo contro i capelli lunghi.
Seguiranno una serie di interventi sulla politica, sul costume, sulle istituzioni, che saranno raccolti nel volume “Scritti corsari” che l’autore riuscì a vedere pubblicare prima di morire.
Ogni pezzo suscitava reazioni sulla stampa e specialmente le critiche stimolavano una contro risposta pasoliniana.
Il suo sogno si era avverato. Era diventato il geniale comunicatore, l’analista più seguito della società italiana, il pedagogo provocatore, lo psicologo dei comportamenti, un testimone scomodo ed ingombrante.
Vale la pena citare alcuni temi trattati nei suoi articoli. I capelli lunghi : “È giunto il momento di dire ai giovani che il loro modo di acconciarsi è orribile, perché servile e volgare”. Sullo slogan dei jeans “jesus” “non avrai altri jeans al di fuori di me: il fascismo non ha nemmeno scalfito la Chiesa, mentre oggi il Neo capitalismo la distrugge”. E sul consumismo: “Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi”.
Altri argomenti verso i quali si indirizzavano gli strali pasoliniani furono il fascismo degli antifascisti, lo sviluppo, il progresso tecnologico, la globalizzazione, il potere del Palazzo, il provincialismo della società italiana, la cultura che nell’università, nel giornalismo, nella letteratura, è incapace di cogliere i segni dei tempi.
A rigore non è che i suoi giudizi presentano cambiamenti rispetto alle sue idee precedenti.
Ma la possibilità di essere ospitato dal primo quotidiano italiano rende il suo stile meno retorico, più efficace anche dal punto di vista della comunicazione.
Alcune prese di posizione, famosa quella ad esempio quella – contro l’aborto – fecero si che l’autore trovasse estimatori e difensori più a destra che a sinistra.
Ben poco da aggiungere sul libro postumo “Lettere luterane” che vede un Pasolini riprendere i temi corsari, ma in un quadro apocalittico e drammatico.
La “vera tragedia italiana” è la droga che occupa il vuoto lasciato dalla mancanza di valori. Così per l’eliminazione della criminalità in Italia, il “luterano Pasolini” propone due “modeste proposte”: l’abolizione della scuola dell’obbligo e della televisione.
Torniamo ora alla notte tra il 1° e il 2 novembre del 1975 che vide la morte del poeta, non certamente angelica come ebbe a definirla Edoardo De Filippo. Un complotto politico l’insostenibile tesi di molti, tra i quali spiccò Oriana Fallaci. Una fine attesa, prevista e non evitata secondo il cugino Nico Naldini.
Una sciocchezza, quest’ultima, secondo l’amico Moravia. A un pittore e ad un amico da sempre, Giuseppe Zìgaina, và la ricostruzione (o la fantasia?) più originale.
Pasolini - secondo questa tesi – scelse l’anno, il mese, il giorno e il luogo della propria morte. Aggiunge di più. La prima decisione di suicidarsi era stata presa nella domenica dei Morti del 1969.
Ma qualcosa gli fece spostare la data: l’ingresso nella sua vita di Maria Callas. A Pasolini era già capitato di rimanere colpito da Silvana Mangano, ma solo perchè in lei aveva visto una somiglianza fisica con la madre; ora era rimasto letteralmente affascinato dalla cantante interprete della sua “Medea”.
La Callas nulla sapendo della sua omosessualità, si era innamorata di lui e quando il poeta le regalò un anello, lei lo baciò con trasporto pensando a una richiesta di matrimonio.
“Bisognava vedere gli occhi sbarrati di Pasolini in quel momento” , racconta l’amico pittore.
Sarà in un viaggio fatto insieme in un’isola deserta dell’Egeo che la cantante si renderà conto dell’impossibilità del suo amore.
Per il poeta fu soltanto il soggetto di questi versi. “Così (ed è la prima volta, ripeto, che mi succede) i miei occhi prendono in considerazione i lombi immondi di donna, di carne d’uomo non fatta a somiglianza di Dio, preda del serpente e affabulo d’amore ha PsiKiKò”. Coincidenza vuole che quella morte prima fissata per domenica dei Morti 2 novembre del 1969 avverrà domenica dei Morti 2 novembre del 1975, data scelta perché doppiamente sacra.
In conclusione, una curiosità.
Tra i commenti e sulla morte del poeta giudicati più scandalosi vi è quello apparso sulla “Gazzetta del Sud” per la penna del suo direttore Nino Calarco: “La sua scontata morte violenta non ci turba, né ci commuove, né ci emoziona. Pasolini, figlio dell’Italia del boom economico e dello sviluppo anomalo non cessò mai di rinunciare alla sua euforia vitale espressa in autentiche notte di violenza psicologica e fisica, com’era abbastanza noto a tutti e come è stato confermato dal fatto del suo ultimo incontro. Quello che non accettiamo e respingiamo è l’omosessuale perverso come Pasolini, cioè colui che si fa non solo apologista del costume contro la storia… ma al servizio della sua diversità impone grazie al successo e alla notorietà la sua falsa scienza, la sua falsa psicologia, spingendosi, per opportunismo commerciale, fino all’ignominia della propaganda politica che in Italia aggiunge confusione a confusione” .
Verrà presentata denuncia contro Calarco per apologia di reato, archiviata dalla magistratura.
Eppure l’analisi del siciliano, passionale Calarco ci sembra meno impietosa di quella, fatta sul “Guerin sportivo” , dal padano, freddo, Gianni Brera. “Mi rimane tutt’ora nella memoria come una sorta di sgomento: (si riferisce alla faccia dello scrittore vista in una trasmissione tv) gli occhietti vivi e pungenti, la fronte ampia, bozzuta e insieme degenerata per chissà quali sconquassi ereditari, gli zigomi alti e sporgenti, il nasetto breve, la bocca larga da femminota riuscita male, il mento peraltro ossuto e quadrato, in imbarazzante contrasto con l’espressione, che era del satiro conscio di sé e della propria dannazione armonica. Incasellato nel mio archivio mnemonico, quel personaggio era già condannato al triste suo destino, ed a pensarci, ha ottenuto, la fine che forse cercava, quasi irridendo allo scandalo cui lo costringeva la sua ambigua natura. Ad accopparlo in quel modo orrendo è stato un ragazzo di vita quali egli stesso aveva scoperto e reso popolare. Era la fine di un poeta maledetto ma con “Alfa Romeo” e conto in banca”.




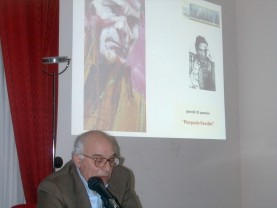
AA. VV., "Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte", Garzanti, 1977;
E. Siciliano, "Vita di Pasolini", Bur Rizzoli, 1981;
N. Naldini, "Vita di Pasolini", Einaudi, 1989;
E. Golino, "Pasolini - il sogno di una cosa", Bompiani, 1992;
P.P. Pasolini, "I dialoghi", Editori Riuniti, 1992;
V. Mannino, "Invito alla lettura di Pasolini", Mursia, 1993;
P.P. Pasolini, "Saggi sulla politica e sulla società", Meridiani Mondadori, 1999;
G. Zigaina, "Pasolini e la morte", Marsilio, 2005.