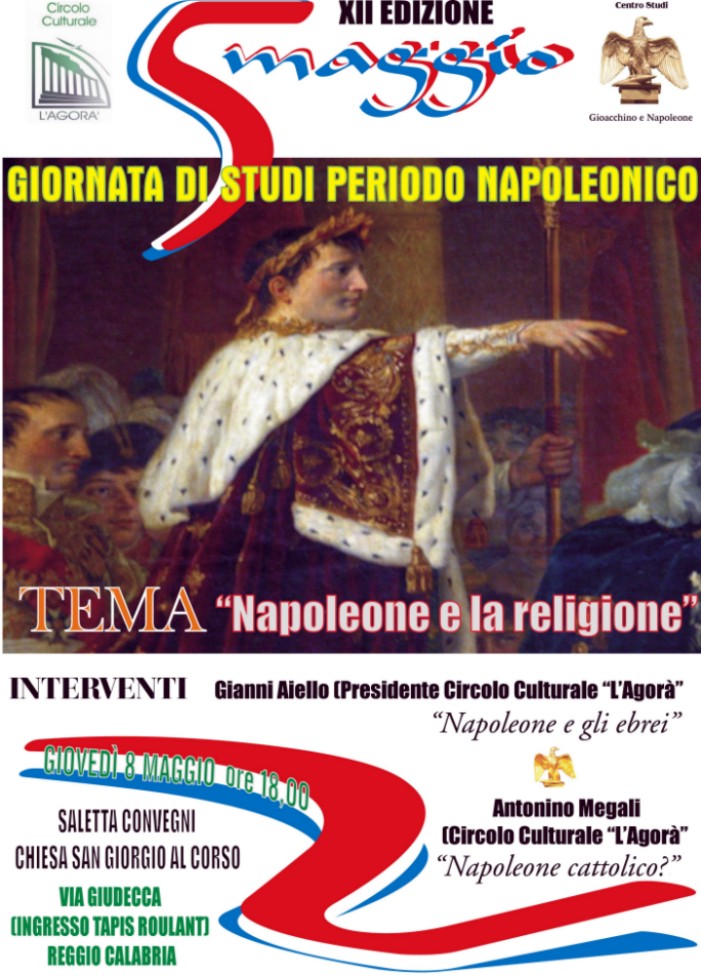Si passa quindi alla lettura della relazione di Vincenzo Cataldo:
«Un’orrenda rivoluzione fisica ha riempita di desolazione, di devastamento, e di strage la parte maggiore della Calabria Ultra». Così esordiva nella sua cronaca Michele Sarconi nel descrivere il catastrofico sisma che il 5 febbraio 1783 devastò la regione nella sua estensione più meridionale. Le vittime ammontarono a 29.515 e i danni alle cose a 31 milioni e 250 mila ducati.
Il terremoto pose fine, da un punto di vista antropologico, alla cappa di isolamento che aveva avvolto la Calabria fino a quel momento. Il governo e l’intellettualità non solo italiana ma anche europea, cominciarono ad interessarsi di quest’area “classica” tutta da riscoprire e sulla quale indagare secondo i principi di quell’esprit des lumières ben vivo nella cultura del tempo.
I tecnici e gli uomini di scienza della Napoli illuministica ebbero il compito di indagare direttamente suoi luoghi lo stato delle cose e delle persone di questo mondo nascosto da una cortina invisibile e improvvisamente spuntato fuori grazie allo scombussolamento subìto.
Lo stato quasi primitivo in cui si trovava la Provincia veniva fatto risalire principalmente al suo isolamento geografico e territoriale. L’antica via Popilia era stata ridotta a mulattiera per il transito dei postali, di qualche avventuriero o per il piccolo commercio e le vie di attraversamento del litorale jonico erano demandati in genere alle imbarcazioni. Inesistenti i ponti sulle due fiumare; nel corso dell’inverno non era quasi possibile collegarsi con gli altri paesi interni.
A tal riguardo Gianni Aiello informa l'uditorio che in diverse occasione sono stati evidenziati attacchi pirateschi ad imbarcazioni che dalla fascia jonica e non solo transitavano per scopi commerciali.
Ritornando alla relazione di Vincenzo Cataldo:
Lo stesso abate Ferdinando Galiani, segretario del Supremo Magistrato del Commercio, auspicava un intervento che tenesse conto delle esigenze delle classi più povere e metteva in guardia il governo dalle persone «che – faceva notare - potrebbero profittare dell’attuale ruina de’ luoghi per ingrandirsi comprando a vilissimo prezzo i terreni e le case dirute o facendosi censi perpetui».
Le sedute d’asta per la vendita dei terreni confiscasti erano molto laboriose (potevano durare settimane). Quindi anche per partecipare ad un’asta occorreva essere possidenti, poiché serviva un dispendio di tempo e di danaro che non tutti erano in grado di sostenere.
Pochi massari, la borghesia cittadina e di campagna furono coloro che ebbero i benefici dalle operazioni di vendita della Cassa Sacra. Fu con questa che si crearono i presupposti affinché il ceto medio divenisse egemone nello scacchiere del potere, grazie proprio alla frantumazione del patrimonio ecclesiastico.
L’Istituto rappresentò il momento topico per quel potenziale quanto auspicato passaggio dalla concezione feudale ad un rapporto più moderno della società, ma il risultato fu deludente se si pensa che le vendite furono limitate solo al 3 per cento delle terre disponibili; quasi tutti i compratori erano già ricchi proprietari; i contadini, destinatari principalmente della legge, rimasero completamente fuori dall’affare.
Tra gli acquirenti affiora il patriziato di Gerace, ma si fanno avanti anche famiglie benestanti che fanno parte del ceto borghese come i medici Malafarina e Lombardo, il mercante Ruggiero e il massaro Frascà. A questi si aggiungono anche personaggi dell’aristocrazia dei centri vicini (Ardore, Bovalino e Roccella).
Dal punto di vista politico anche nel Distretto di Gerace si diffusero i prìncipi sanciti dalla Rivoluzione francese e 12 paesi furono coinvolti nella nuova esperienza politica che condurrà alla Rivoluzione napoletana del ‘99. La Calabria a quei tempi era descritta dal Visitatore Generale del Regno Giuseppe M. Galanti come una Regione caratterizzata da abusi di varia natura; in cui regnava l’ignoranza, la miseria e il fanatismo; in cui perdurava l’ingiustizia e nella quale dominava incontrastato il contrabbando di qualsiasi merce, praticato da tutte le classi sociali, compresi i preti.
Dai documenti chiaramente la partecipazione di molti calabresi del Distretto di Gerace a quelle vicende, alcuni forse spinti dal momento emozionale, altri da autentiche convinzioni politiche maturate nel nuovo clima determinato dalla Rivoluzione francese dieci anni prima. Nonostante il forte incitamento e i ripetuti appelli delle autorità centrali e periferiche, dagli atti si capisce che la richiesta di armarsi e di far parte della milizia era stata accolta tiepidamente: a Riace c’era chi adduceva mali fisici, chi affermava di non poter partire perché aveva figli piccoli da mantenere e di avere in casa congiunti in età avanzata, chi di aver già prestato servizio militare per tanti anni. In casi particolari, allorché una persona si era resa protagonista di altri reati, conveniva invece arruolarsi per evitare le maglie della giustizia; altri decidevano di farne parte perché attratti dalla paga. Un volontario di Grotteria aveva pensato di affittare la cavalcatura del proprio mulo alla causa, ma arrivato a Borgia durante la notte gli fu sottratto. Per cui «piangendo», così è scritto, se ne ritornò a casa.
Frequentemente le pretese dello Stato cozzavano con lo stato indigente della popolazione, il cui sostentamento era riposto esclusivamente nelle braccia dei lavoratori. Contadini e artigiani, per quanto possibile, cercavano di evitare l’arruolamento, proprio per potersi dedicare alla cura delle loro famiglie. I braccianti costituivano la categoria sociale più numerosa della popolazione attiva, sottoposta ai lavori più pesanti e la loro presenza era estremamente necessaria alla stessa sopravvivenza del nucleo famigliare. Riguardo al 1799, i documenti notarili confermano che il popolo ricadente in questa fascia costiera partecipò con poco entusiasmo a quegli avvenimenti promossi da entrambe le parti, e quando lo fece fu perché costretto o attratto dal guadagno.
Da quanto emerge dall’esame degli documenti, molti manifestarono una celata refrattarietà all’arruolamento volontario a difesa del sovrano, anche se sappiamo di una leva forzosa istituita dal sindaco di Riace.
Diversi, alla fine, presero parte all’esercito sanfedista del cardinale Ruffo. Alcuni soldati tornati da Napoli chiesero alle autorità di potersi riposare nelle loro abitazioni e prepararsi, essendo privi di tutto, prima di ripartire col Cardinale. Un altro volontario dalla guerra ne aveva tratto guadagno in seguito al saccheggio fatto in molti palazzi della Capitale.
Dopo la reazione, non mancarono le accuse di giacobinismo e molti trovarono l’occasione di maturare antiche vendette. Testimonianze furono vergate a favore prevalentemente del ceto medio, di professionisti accusati del cosiddetto «delitto di giacobinismo». Si tratta di persone colte, che avevano viaggiato e curato contatti con altri intellettuali; uomini immersi nella lettura di opuscoli e libri riguardanti le nuove idee. Di giacobinismo fu accusato Don Francesco Lombardo di Gerace e il dottore in legge Gaetano Barbaro di Grotteria. Anche uno studente fu arrestato con l’accusa di giacobinismo, a cui facevano da contraltare deposizioni di alcune persone che lo avevano visto arruolato tra le fila dell’esercito borbonico alcuni anni prima. Sono vicende che testimoniano la drammaticità del momento, in cui l’accusa poteva tramutarsi in delazione, come accadde al subalterno della Regia Udienza (corrispondente all’attuale Corte d’Appello) Luigi Giordano che, incriminato di giacobinismo, affermò che in caso di assoluzione avrebbe fatto pagare cara l’azione ai suoi accusatori.
Ai fatti del ’99 fu anche coinvolta la famiglia Caristo di Stignano. A Stilo era stato il notaio Vincenzo Candido a infiammare gli animi contro il re, iniziando dal casale di Stignano con l’incitare la popolazione alla rivolta. Ai suoi discorsi aveva aderito l’amministratore Francesco Martelli, imprigionato poi nel carcere di Nicotera e nel quale furono anche fatti rinchiudere successivamente dal Cardinale Ruffo i deputati del popolo Domenicantonio Contestabile e Ferdinando Castagna.
A riguardo i fatti ed i personaggi originari dell'area jonica della provincia reggina protagonisti nella Repubblica partenopea Gianni Aiello parla di Vincenzo Fabiani che fa da cerniera ai periodi storici relativi al 1799, alla prima restaurazione, al decennio ed alla seconda restaurazione borbonica.
Vincenzo Fabiani nacque a Grotteria il 13 febbraio 1778 da Pietro e Caterina Barillaro. intraprese i primi studi nel seminario di Gerace concludendoli a Napoli dove, il 27 giugno 1801, si laureò in “utroque iure”, locuzione latina che indica la laurea in diritto civile e canonico.
Durante il periodo della Repubblica napoletana svolse le mansioni di commissario del potere esecutivo nel cantone di Gerace e si distinse nella battaglia di Vigliena del 13 giugno del 1799 e dopo la caduta della Repubblica conobbe l'esilio, fu a Marsiglia.
In seguito Napoleone Bonaparte gli conferì la carica di reggente della sottointendenza di Gerace e successivamente assume i gradi di capitano della guardia provinciale di Calabria ultra per Grotteria e Martone.
Partecipò alla conquista di Scilla al seguito del generale francese Louis Eugène Cavaignac.
Nel 1808 si ritirò dalla vita militare per proseguire l'attività amministrativa sino al 1815: si spense a Grotteria il 22 dicembre del 1823 nella città natale che gli intitola una via con la dicitura “Vincenzo Fabiani, capitano napoleonico”.
Prima di continuare alla lettura della relazione di Vincenzo Cataldo, Gianni Aiello ha ricordato anche le fonti che riguardano il territorio della provincia jonica reggina nel contesto storico del decennio francese.
Tra esse oltre ai documenti d'archivio, vi sono quelle relative ai mezzi d'informazione del periodo, come il Monitore Napoletano, la Gazzetta Britannica o diverse pubblicazioni, tra le quali quelle di:
- Duret de Tavel, “Viaggio in Calabria ” ;
- “Primo moderno reportage sulla Calabria vista all’alba del 1800 da un ufficiale napoleonico” ;
- L’occupazione francese della Calabria” di Lubin Griois;
Ma anche la testimonianza di un prigioniero britannico che descrive in modo dettagliato sia la fascia jonica che quella tirrenica: si tratta del tenente Philip James Elmhirst che dal 23 settembre 1809 al 16 aprile 1810 fu prigioniero di guerra da parte delle truppe napoleoniche di stanza nel territorio meridionale.
Egli venne catturato, insieme al suo equipaggio, nei pressi di capo Stilo, dove erano sbarcati per fornirsi di acqua.
Dalla cattura , al periodo della quarantena nei pressi di bianco, alla dettagliata descrizione degli usi, costumi, personaggi, fatti, personaggi, cronaca (atti di brigantaggio, scontri armati tra truppe francesi ed i loro avversari, transito di navi nelle acque della provincia reggina), descrizione architettonica delle abitazioni di quel periodo, il tipo di alimentazione la coltura nelle campagne della provincia, quali quelle relative alle produzioni dell’olio e del vino.
Ritornando alla cronaca, Gianni Aiello ha raccontato del viaggio di Giuseppe Bonaparte nel Distretto di Gerace: il 20 aprile 1806 parte dalla Città dello stretto per dirigersi successivamente nella fascia jonica reggina, visitando i centri di Brancaleone (20 aprile), Monasterace (22 aprile).
Il 25 aprile fu in quel di Mammola e durante il suo passaggio gli abitanti indossavano sul capo delle corone di spine e si battevano il petto con pietre rotonde: questo è un dato storico-antropologico importante, in quanto notizie relative all’esistenza di confraternite dei “battentes” o “fustigantes” nella provincia reggina se ne hanno soltanto qualche secolo prima.
Infatti ciò si può evincere dalla lettura de “La pietà popolare in Calabria” di Maffeo Pretto che parla dell’esistenza presso la chiesa di S.Gregorio di Gerace, ed anche di altre confraternite di battenti presso Roccella Jonica.
Il 28 aprile Giuseppe Bonaparte visitò Gerace ed ebbe un incontro con l’arciprete della diocesi del periodo.
Gianni Aiello prosegue con l'analisi della relazione sul Distretto di Gerace di Vincenzo Cataldo:
La vicenda rivoluzionaria, come ben noto, finì con il ritorno sul trono della stirpe borbonica. Qualche anno dopo, mutato lo scacchiere geopolitico europeo, quando il 14 febbraio 1806 entrarono a Napoli, i francesi immediatamente cercarono di stendere un progetto per la formazione della Guardia Nazionale. E vediamo perché.
Un’anonima relazione (ma non è difficile individuarne l’autore nel ministro Michelangelo Cianciulli, noto come promulgatore, in veste di ministro di giustizia, delle leggi eversive sulla feudalità), un’anonima relazione - dicevamo - sulla situazione generale del Regno investe il nuovo re Giuseppe Bonaparte. Nel documento si fa ampio riferimento alla nuova organizzazione della pubblica amministrazione per rispondere alle esigenze di uno Stato moderno.
Il Regno di Napoli, inserito nello Stato federativo dell’Impero Francese, affermava sostanzialmente il ministro, non avrebbe potuto temere, come prima, gli assalti degli eserciti nemici, ma solo guardarsi dagli intrighi interni.
Durante le visite delle province compiute da Giuseppe Bonaparte, i villaggi più poveri, invece di chiedere pane domandavano giustizia. Cianciulli si riferiva al vecchio sistema giudiziario in cui ancora i feudatari avevano voce in capitolo. Tre quarti del Regno erano soggette al regime feudale, commentava: i giudici dei baroni avvolgevano i governi locali commettendo estorsioni; l’esecuzione della giustizia era affidata a birri e bargelli degli stessi feudatari, «che da loro - rilevava nella sua analisi - ne ricevono uno scarso salario, e che per non perderlo divengono i satelliti de’ loro capricci e delle loro vendette». La stessa natura criminosa veniva ravvisata negli uomini facinorosi presenti nelle Regie Udienze.
Dunque, considerata la giustizia male amministrata il ministro constatava che, «chi per offendere, chi per difendersi, quasi tutti vanno armati di bajonetta, di stiletti, di pistole, e di fucili». Era quasi inevitabile il vedersi moltiplicare gli omicidi, i furti, le rapine e le violenze d’ogni genere, generatori di gravi fenomeni sociali.
Cianciulli non attribuiva la completa responsabilità al passato governo borbonico, il quale per mancanza di validi consigli e di un’energica azione, non aveva potuto conseguire gli opportuni risultati. In verità, i borboni avevano cercato di abbattere quello che veniva definito dai francesi come il «Mostro feudale», concedendo senza giurisdizione i feudi devoluti ed obbligando i governatori ed i birri baronali a non poter esercitare l’ufficio senza l’approvazione delle Regie Udienze. Rimedi lenti, dall’una parte, e pochi efficaci dall’altra. D’altronde il rallentamento della giustizia non si riduceva nelle soli corti baronali, ma era radicato nelle Regie Udienze e in tutti i Tribunali di Napoli e delle Province.
Punto fondamentale per rimuovere gli ostacoli frapposti ad una più moderna amministrazione della giustizia, rimaneva la questione della sicurezza. Assieme alla truppa di linea che difendeva lo Stato dalle aggressioni straniere e alla gendarmeria impiegata nella sicurezza delle strade e delle campagne, si poneva come elemento indispensabile, secondo il ministro, l’istituzione della guardia nazionale, in modo da rimpiazzare i birri e i bargelli dei baroni, nonché i soldati dei tribunali e delle dogane. La guardia nazionale prestando un servizio gratuito, immediato e locale era la sola capace ad assicurare, secondo il progetto del relatore, la giustizia ed a prevenire nella massima parte i delitti. Un corpo «rispettabile di Guerrieri», come veniva definito, in grado di combattere per le loro famiglie e per il sovrano.