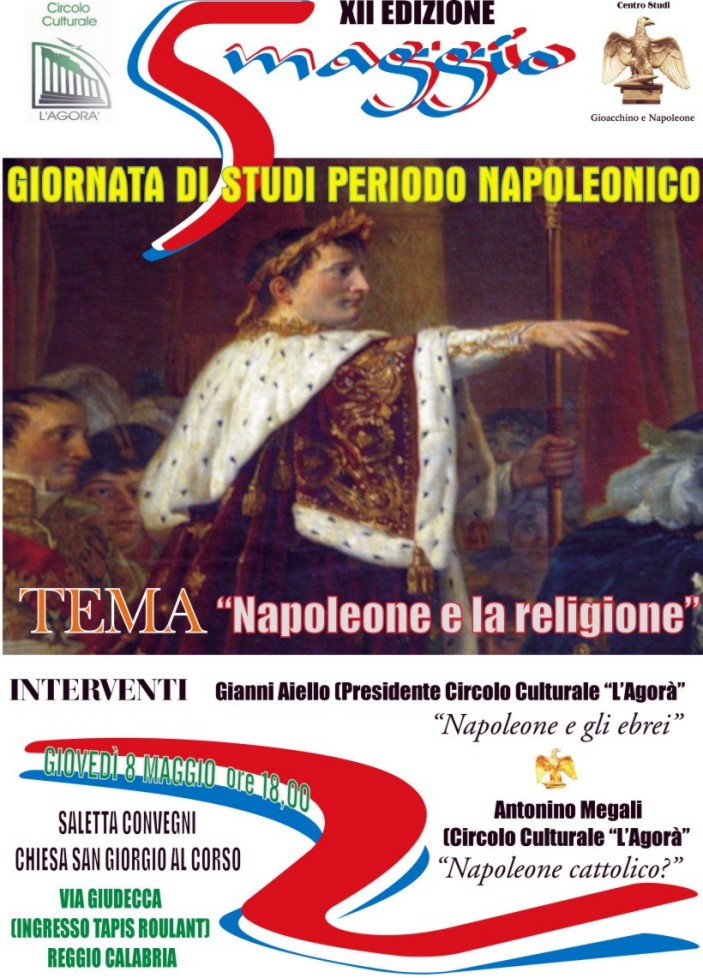
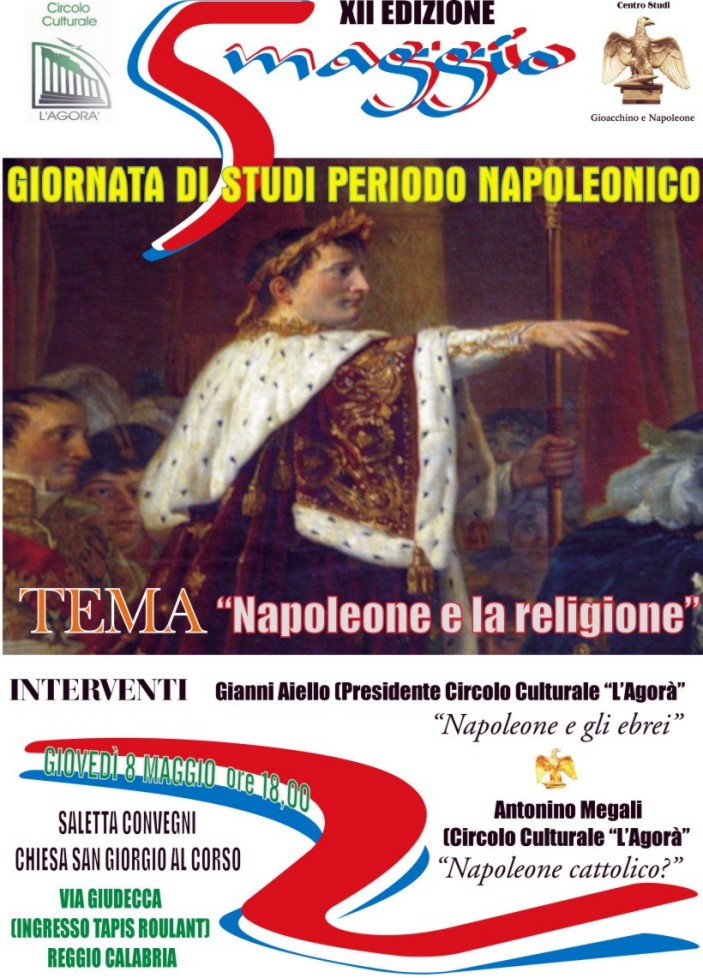

La dodicesima edizione denominata “5 maggio” organizzata dal Circolo Culturale "L'Agorà" e dal Centro studi "Gioacchino e Napoleone" ha trattato il tema relativo a “Napoleone e la religione” spostando quindi il baricentro della figura dello stratega verso quello della fede religiosa.
Gli argomenti trattati sono stati quelli inerenti a “Napoleone e gli ebrei” a cura di Gianni Aiello e “Napoleone cattolico?” il titolo del tema trattato da Antonino Megali.
Durante l'assedio di San Giovanni d'Acri (20 marzo-21 maggio 1799) secondo lo storico Bernhard Blumenkranz, Napoleone Bonaparte con la stesura di un decreto annunciava la costituzione di uno Governo ebraico indipendente sul territorio Palestinese.
Nella stessa città il giovane corso inserisce in quelle disposizioni anche quelle relative alla formazione di un organo consiliare degli Ebrei dell'Egitto e, secondo le intenzioni di Napoleone Bonaparte vi era in programma un secondo proclama della stessa natura.
E di quanto sopra evidenziato vi è come testimonianza una pubblicazione apparsa sulla “Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel” del 22 maggio 1799 (3 pratile, Anno VII) dove il giovane corso “... invita gli ebrei dell'Asia e dell'Africa a coalizzarsi con l'Armata francese per la ricostituzione dell'antica Gerusalemme ...”, tale notizia è datata Costantinopoli, 28 Germinale. (1)
Tale programma non venne attuato in quanto l'esito delle operazioni militari assunsero diversi scenari.
Comunque, si riporta il testo di tale linea programmatica inerente alla Proclamazione della Nazione Ebraica che avrebbe dovuto riportare la data del 20 aprile 1799 (1°floreale, Anno VII) e per le circostanze logistiche sopra evidenziate non venne attuato.
Si tratta, in buona sostanza del primo testo sionista, anticipando di un secolo ciò che si sarebbe verificato in seguito, e nel contempo propone una considerazione inerente al tema del riscatto dei popoli.
Questo il testo:
[...] Napoleone Bonaparte,comandante in capo delle armate della Repubblica francese ,in Africa e in Asia,
agli Ebrei,
eredi legittimi della Palestina,solo popolo ,che le conquiste e le tirannidi ,patite per migliaia di anni, hanno privato della terra dei propri antenati,ma non del loro nome e della loro identità di nazione!....
In piedi,
per la vostra felicità, o esiliati! Questa guerra ,senza esempi nella Storia,è stata fatta a sola difesa di una nazione ,le cui terre d'origine erano per i suoi nemici preda offerta da smembrare. Ora questa nazione si vendica di duemila anni di vergogna......La Provvidenza mi ha mandato ,capo di un'armata giovane,sotto la guida della giustizia e in compagnia della vittoria. Gerusalemme è il mio quartier generale;fra pochi giorni sarò a Damasco,la cui prossimità la città di Davide non dovrà più temere.
Eredi legittimi della Palestina!
La Grande Nazione(la Francia),che non baratta uomini e paesi come coloro che hanno venduto a tutti i vostri antenati (Joel I Cronache 5,4-6),non vi chiama alla conquista del vostro patrimonio. No,vi chiede di divenire padroni di quello che lei ha conquistato. E, sotto la sua protezione e con il suo aiuto,vi chiede di essere i signori di questa terra e proteggerla dai nemici ,che non mancheranno.
Alzatevi!
Dimostrate che la forza dei vostri oppressori non ha potuto distruggere il coraggio di chi discende da eroi che avrebbero fatto l'onore di Sparta e Roma.(Macc.12,15)
Mostrate
che duemila anni di schiavitù non hanno soffocato questo coraggio.
Affrettatevi!
è il momento e forse non tornerà se non tra mille anni,di reclamare la restituzione dei vostri diritti civili,di occupare il vostro posto in mezzo agli altri popoli,nel mondo. Avete il diritto ad esistere politicamente ,perché siete una nazione fra le altre nazioni. [...]
Quindi, quanto sopra evidenziato anticipa le teorie sioniste dell'ungherese Theodor Herzl (Pest, 2 maggio 1860 – Vienna,3 luglio 1904) e così come riportato nella pubblicazione di Jaques Attali " Les Juifs, le Monde et l'Argent " . (2)
A tal riguardo – prosegue Gianni Aiello, vorrei citare quanto il giornalista del Corriere della Sera Paolo Mieli ebbe a scrivere in un suo articolo “Il principe Potëmkin, l'imperatore Napoleone e il presidente degli Stati Uniti John Adams, scrive Montefiore, «credevano tutti nel ritorno degli ebrei a Gerusalemme al pari dei nazionalisti polacchi e italiani e naturalmente dei sionisti cristiani in America e in Gran Bretagna». Di qui nacque il sionismo. (3)
C'è da evidenziare che i contatti tra Napoleone Bonaparte ed il mondo ebraico non furono solo quelli relativi alla Campagna d'Egitto, ma anche in altre circostanze precedenti a quanto sopra evidenziato.
Il problema ebraico in Francia era oggetto di discussione durante il periodo rivoluzionario come attestano diversi dibattimenti su tale tema.
Il 3 agosto del 1789 il priore Henri Gregoire, deputato agli Stati Generali, portava all'ordine del giorno il problema ebraico in quella seduta dell’Assemblea Costituente. Il 27 settembre del 1791 i contenuti dei principi costituzionali relativi ai “diritti dell’uomo e del cittadino” vennero estesi anche alla comunità ebraica che in quel periodo annoverava circa 40.000 unità di residenti sul territorio francese.
Questo fu un successo da parte di Henri Gregoire che poneva all'attenzione pubblica tale problema sin dal 23 agosto del 1788 quando vinse un concorso promosso dall'Accademia Reale delle Scienze e delle Arti di Metz sul tema: «Ci sono dei mezzi per rendere gli Ebrei più utili e felici in Francia?» . (4)
Inizia la Campagna d'Italia (11 aprile 1796 – 17 aprile 1797) e Napoleone Bonaparte ne guida l'Armata durante le operazioni della prima guerra di coalizione combattuta dalla Francia rivoluzionaria.
La prima “agorà” nella Penisola con la comunità ebraica da parte di Napoleone Bonaparte avvenne ad Ancona il 9 febbraio 1797, dove quella collettività viveva nell'apposito quartiere e gli abitanti del ghetto indossavano copricapo di colore giallo e bracciali con la Stella di Davide.
Quegli elementi di riconoscimento vennero aboliti insieme alle leggi relative all'Inquisizione e tali provvedimenti vennero in seguito estesi anche alle comunità residenti a Roma , Venezia , Verona e Padova .
Quindi a seguito delle vittorie rivoluzionarie anche nella Penisola vengono attuate le nuove disposizioni relative all'abrogazione delle vecchie linee guida sulle differenze religiose.
A testimonianza di ciò si registra a Bologna al momento dell'impianto dell'Albero della Libertà il posizionamento su di esso le icone della giustizia: le Tavole della Legge.
Ad Ancona tre cittadini della comunità ebraica di quella città entrano subito a far parte del Consiglio comunale, così come a Venezia dove vengono nominati anche nei ranghi militari della Guardia Civica.
Il termine "cittadino" entra nell’uso comune anche nella comunità ebraica (si dice per esempio: "Cittadino rabbino") e tutti i loro documenti sono intestati con gli acronimi: libertà, fraternità, uguaglianza.
Nel settembre del 1797 il generale Antoine Christophe Saliceti a Bologna emana un editto con il quale viene estesa la libertà di culto anche alla comunità ebraica.
Il 10 febbraio 1798 il generale Louis Alexandre Berthier entra a Roma ed il 15 dello stesso mese l’Albero della libertà viene eretto nel ghetto.
Tale “primavera riformatrice” muta bruscamente nel marzo del 1798 quando, a seguito della Campagna d'Egitto, la Penisola italiana rimane sguarnita e ciò permette ai “fuoriusciti” di riprendere possesso dei territori.
Quelle insorgenze interessarono anche le varie comunità ebraiche sparse sul territorio che subirono le conseguenze di quelle reazioni.
Diversi furono gli episodi riportati nella letteratura sia storiografica che di cronaca del periodo:
Molti cittadini ebrei si rifugiarono nella città di Ancona, dove vigeva l'amministrazione napoleonica.
Nella città dorica il generale Jean-Charles Monnier stabilì con un apposito decreto che tutti i cittadini sono uguali senza differenza di religione.
Napoleone Bonaparte rientra in Francia dall'Egitto il 9 settembre del 1799 e dopo gli avvenimenti del 18 brumaio dell'anno VIII (9 novembre) promulgò una nuova costituzione e successivamente riorganizzò l'esercito.
Il 10 febbraio del 1800 vi fu una seconda ondata di operazioni militari in Italia.
A seguito di ciò venne affrontato la problematica relativa alle “insofferenze” nei confronti degli ebrei residenti nella Penisola che si verificarono nei periodi sopra evidenziati.
Quando Napoleone Bonaparte ritornò in Francia nel gennaio del 1806,
dopo la campagna contro gli Austriaci conclusasi con la battaglia di battaglia di Austerlitz (2 dicembre 1805), nella città alsaziana di Strasburgo venne a conoscenza delle problematiche relative alla comunità ebraica.
A seguito di ciò, il 30 maggio dello stesso anno dispose un decreto nel quale stabiliva che si convocasse un'apposita “assemblea di rabbini, proprietari ed altri ebrei notabili del suo vasto dominio, onde rianimare i sentimenti della morale civile e trovare il modo per richiamare [...] l'esercizio delle arti e professioni utili al fine di sostituirle all'usura. L'Assemblea si riunì per la prima volta il 26 luglio di quell'anno ed ebbe come compito quello di rispondere a 12 domande poste da Napoleone e riguardanti le conseguenze civili e politiche delle leggi mosaiche (poligamia, divorzio, matrimonio interconfessionale, rapporti coi francesi, appartenenza nazionale, organizzazione e potenza del rabbuiato), le professioni e, infine, l'usura contro i correligionari e contro coloro che professavano un'altra religione.
(5)
Il 26 luglio del 1806 a Parigi venne indetta la consulta alla quale parteciparono centoundici notabili di cui 82 provenivamo da diversi luoghi dell'Impero, mentre 13 erano piemontesi ed altri 16 provenivano dalle altre parti della penisola italiana.
Tali assemblee si svolgevano presso la chiesa parigina sconsacrata di San Giovanni , mentre altre riunioni si tenevano presso l'Hotel de Ville, dove “ secondo un'antica usanza , i settanta membri disposti a semicerchio intorno al presidente , dal rango di età . Poiché le sessioni erano pubbliche , abbiamo sempre visto molti assistenti . I membri del Sinedrio erano tutti vestiti di nero , con un piccolo mantello di seta e un tricorno in testa “. (6)
Tali adunanze erano erano presiedute dal banchiere della città di Bordeaux Abraham Furtado e proseguirono fino al 6 aprile del 1807.
Nello stesso anno vennero redatte le conclusioni di tali consulte con la convocazione del Gran Sinedrio (4 febbraio – 9 marzo).
Per quelle assemblee vennero invitati figure di rilievo sia del rabbinato dell'Impero francese che del Regno d'Italia , tra i quali 71 fra dottori della Legge e notabili d'Israele, più i supplenti rabbinici e laici, i verbalizzatori, gl'ispettori di sala e gli scribi - e formulò dodici domande per chiarire la posizione ebraica su una serie di questioni religiose, sociali e politiche. (7)
Le decisioni conclusive vennero poi trasferite in appositi regolamenti e successivamente raccolti nel decreto napoleonico del 17 marzo 1808 che regolava in modo organico il nuovo istituto e decretava l’ebraismo come terza religione ufficiale.
A seguito di ciò vennero riordinate le geografie amministrative con l'organizzazione dei concistori locali .
Questo programma ebbe numerosi consensi ma anche delle critiche sia da un'area della comunità ebraica che non approva le decisioni di Napoleone Bonaparte (8), sia dalla chiesa ortodossa moscovita, unitamente a quella luterana di Prussia e lo zar Alessandro di Russia lo definì come “Anticristo e nemico di Dio”. (9)
Nel corso di quelle linee programmatiche Napoleone Bonaparte “ […] volle esaminare il problema ebraico: nel 1806 esso fu discusso due volte al Consiglio di Stato; e in lui maturò l’idea di convocare il Sinedrio. Un Napoleone non poteva accontentarsi di una semplice Assemblea rappresentativa; doveva essere il Sinedrio, come nei tempi antichi, autorevole e venerando come l’antico Sinedrio, di cui doveva essere una copia precisa. Nel luglio del 1806 si riunì a Parigi l’Assemblea dei notabili ebrei composta da 112 deputati, sotto la presidenza di Abramo Furtado di Bordeaux, per preparare il Sinedrio; che fu convocato nel febbraio dell’anno seguente. Da ogni parte giunsero rappresentanti, anche dalle Comunità italiane: 13 rappresentanti dal Piemonte, 16 da tutto il resto d’Italia. Le figure più significative fra i partecipanti sono il Rabbino di Mantova. Abramo Cologna e Mosè Formiggini, futuro redattore del Codice commerciale del Regno italico. Ma non tutti gli Ebrei sono d’accordo: il rabbino di Marsiglia, un italiano (Costantini di Livorno), invitato a partecipare al Sinedrio, dichiara di non riconoscere l’autorità dell’Imperatore nelle questioni riguardanti gli Ebrei; Jacob Israel Carmi da Reggio ci lascia delle lettere da cui si rileva come non tutti fossero convinti di servire in tal modo la causa dell’ebraismo. Al Sinedrio fu presentata la seguente dichiarazione: "L’Ebreo considera il suo paese natale come sua patria, e ritiene suo dovere difenderla" . E tutti i delegati, in piedi, gridarono: "Fino alla morte!" . Un’ordinanza promulgata l’anno seguente a Madrid disponeva che ogni dipartimento con almeno 2 mila ebrei dovesse avere un concistoro, mentre un Concistoro centrale, con sede a Parigi, doveva controllare le organizzazioni locali. Furono così istituiti in Francia 10 concistori dipartimentali. Quest’organizzazione voluta da Napoleone esiste tuttora in Francia. Ed anche l’Italia ebbe così i suoi concistori. […]”. (10)
Nel dicembre del 1807, a seguito della soppressione del Regno d'Etruria, venne restaurato il Gran Ducato di Toscana e nella primavera del 1808 vennero introdotti alcuni accorgimenti durante lo svolgimento dei rituali liturgici.
Infatti, nella liturgia “Pro Judaeis “del Venerdì Santo vennero sostituite le espressioni “perfidi ebrei”, “perfidia giudaica” considerate poco rispettose nei confronti di quella comunità con altre diciture ritenute meno irriverenti come “accecati giudei”, “giudaica cecità”. (11)
La parità di quei diritti acquisiti durante l'amministrazione napoleonica Napoleone ebbe breve durata e la sua efficacia procedurale si concluse a seguito sia dei risultati della battaglia di Mont-Saint-Jean, nella provincia belga del Brabante Vallonte, (Waterloo,18 giugno 1815 ) che degli esiti del Congresso di Vienna (1º novembre 1814 - 9 giugno 1815).
Il 28 maggio del 1814 a seguito del rientro a Roma di Papa Pio VII vennero ristabilite sia tutte le procedure inquisizionali sia i provvedimenti che annullavano i diritti acquisiti in precedenza dalla comunità israelitica di Roma che a seguito di ciò venne riconfinata nel ghetto, imponendo di frequentare i sermoni.
E tali disposizioni amministrative vennero estese a tutti gli altri Governi ubicati nella Penisola italiana, mentre in Francia, con i rientrati Borbone, non vennero intraprese azioni restrittive nei loro confronti, tranne il restauro dell'Ordine di San Luigi che nel 1830 venne abolito da Luigi Filippo Borbone d'Orléans, duca d'Orléans .
A Sant'Elena , Napoleone ebbe a dire a loro riguardo:[…] li ho resi liberi dando loro diritti uguali a quelli della chiesa Cattolica e protestante […]. (12)
La parola passa ad Antonino Megali che tratta il tema “Napoleone cattolico?” ed a tal proposito, esordisce l’intervenuto evidenziando che Napoleone, da uomo di stato, si comportò con la religione facendosi guidare da quello che al momento gli sembrava più opportuno, come quando ripristinò il culto cattolico in Francia abolito dalla rivoluzione. Di certo non fu mai ateo. Avendo ricevuto una educazione religiosa, non aveva abbracciato la filosofia dei rivoluzionari. Ma, egli diceva, bisogna distinguere gli atti del Sovrano che opera collettivamente da quelli dell’uomo privato. La politica ammette, ordina talvolta, all’uno ciò che sarebbe senza senso nell’altro. Veniamo ora alla guerra ingaggiata con la religione e con i due papi, Pio VI e Pio VII, che durò circa un ventennio. Nel 1793 prendendo a pretesto l’assassinio del segretario della legazione francese a Roma, Ugo Bassville, mosse guerra agli Stati della Chiesa. L’intenzione era di destituire il Papa e proclamare a Roma la repubblica. Pio VI fu costretto a chiedere un armistizio, che ottenne a condizioni pesantissime. Dovette versare ventun milioni di franchi in denaro, quindici milioni in oro e cinque milioni e mezzo in mercanzie, cavalli e bestiame. Scelti da esperti francesi cedette anche cento opere d’arte e cinquecento preziosi manoscritti. I francesi derubarono il Santuario di Loreto, seguendo alla lettera l’ordine del Direttorio:” Portare via dall’Italia tutto ciò che è trasportabile e che può essere in qualche modo utile”.
Nella successiva pace di Tolentino (1797), Napoleone pretese ancora quattordici milioni di franchi come contributo di guerra, mille e seicento cavalli, strumenti, legname, cotone, e perfino piante rare. Ma Napoleone continuava nel suo disegno di occupare lo Stato Pontificio ed eliminare il Papa. Ancora una volta il pretesto gli fu offerto dall’uccisione di un generale francese, Duphot, destinato ad essere anche il futuro marito della sorella minore della moglie di Giuseppe Bonaparte. Le conseguenze furono devastanti. Il Papa fu costretto a pagare ventitré milioni di franchi, mantenere l’esercito francese, consegnare libri preziosi manoscritti e opere d’arte. Questi tributi non lo sottrassero all’arresto. Nel decreto d’arresto Pio VI venne chiamato “Ci-devant Pape “. Ammalato il Papa assistette al saccheggio delle sue stanze private. Gli fu strappato l’anello dal dito e furono tolte le serrature della porte. A questo punto perfino il direttorio protestò e disse che:” Tutto doveva avere un limite, anche il diritto di conquista.”. Quando il Papa manifestò il desiderio di morire a Roma gli fu risposto che si può morire in qualsiasi posto. Infatti morì a 82 anni a Valenza, dove era stato trasferito. Passò un mese prima della sepoltura e due anni prima che il cadavere fosse trasferito a Roma. Con la sua morte dalla Francia era stata certificata la fine del papato e della Chiesa cattolica. In realtà dopo Pio VI fu eletto Pio VII sul quale Napoleone continuò la sua opera di persecuzione. Chiese, infatti, di essere incoronato imperatore dallo stessa Papa. Pio VII affrontò il viaggio in Francia dove subì una serie di umiliazioni che si conclusero con l’atto di superbia finale, quando l’imperatore gli tolse la corona di mano e se la pose sul capo. Lo stesso procedimento fu ripetuto per Giuseppina. Il Papa tornò a Roma dopo circa sei mesi e dopo il fallimento del tentativo da parte di Napoleone di trasferire la sede del papato a Parigi o ad Avignone. Le pretese e le angherie dell’imperatore continuarono . Pio VII talvolta resisteva e talvolta accondiscendeva per non peggiorare i rapporti già tesi. Chinò la testa perfino quando gli fu chiesta la rottura con l’Inghilterra. A questo punto scattò l’arma della scomunica con la Bolla “Ad perpetuam rei memoriam”, nella quale venivano elencate tutte le ingiustizie e i soprusi patiti e si concludeva con la speranza di una conversione dei persecutori.
La notte del 5 luglio 1809 Napoleone comandò l’invasione del Quirinale intimando al Papa la rinuncia del potere temporale. All’ ovvio rifiuto del Pontefice seguì l’arresto ad opera del generale Radet. Primo luogo del suo esilio fu Savona. Le reazioni furono enormi: nelle chiese si pregò per il Papa; l’opinione pubblica si schierò contro l’Imperatore. Mentre Pio VII era prigioniero Napoleone divise in province gli Stati della Chiesa e proclamò Roma la seconda capitale dell’impero francese. Futuro re della città sarebbe stato il figlio che doveva nascere. Dopo Savona il Pontefice fu trasferito a Fontainebleau. Fu costretto a viaggiare vestito da semplice prete di notte, attraversando la città a piedi per poi usare la carrozza fuori città. Intanto arrivò la disfatta della spedizione in Russia, vista da alcuni come una punizione per il suo comportamento contro la religione. (A questo riguardo ci fu chi ricordò quel proverbio francese che recita” qui mange du Pape, en meurt”: chi tocca il Papa muore.) A questo punto la tattica dell’imperatore cambiò e cercò di fare la pace con il Papa. Gli scrisse perfino una lettera nella quale manifestava amicizia, venerazione e stima per la sua Persona. Riuscì così a fargli sottoscrivere un progetto di concordato. Almeno tale era per il Papa, mentre Napoleone l’aveva fatto pubblicare come una accordo definitivo e quando Pio VII gli scrisse un lettera per ritirare quanto aveva sottoscritto la mantenne segreta. Visto finito il suo potere cercò di cambiare tattica.
Incominciò allora a concedere la libertà al Papa prima di finire all’isola d’Elba e poi a Sant’Elena, mentre Pio VII ritornò sul trono pontificio nel maggio 1814.
La Bolla di Scomunica, cui abbiamo prima accennato, non faceva il nome di Napoleone, ma era diretta principalmente a lui ed egli ne fu comunque impressionato. Anche se scrivendo al suo Ministro di culto la definì “un documento così ridicolo, che non merita neppure attenzione”. Ma Talleyrand,prevedendo il futuro, la definì “le commencement de la fin”. Impressionante è la somiglianza fra la sorte toccata a Napoleone con quella che aveva riservato ai due Papi. L’ultima di consegnarsi agli Inglesi sperando nella loro magnanimità per poi, come egli disse, finire ammanettato a dispetto di ogni diritto delle genti.
A questo punto bisogna dare a Napoleone quello che è di Napoleone. Come abbiamo già detto non era assolutamente ateo. Durante il viaggio in Egitto, udendo sul ponte della nave dubbi sull’esistenza di Dio, mostrando il cielo stellato disse:”E quello chi l’ha creato?” Apostrofò un giorno Talleyrand con un “voi siete un uomo senza coscienza , che non credete in Dio!”. Una volta arrivò a cacciare dalla sua camera il suo amico Antonmarchi perché derideva la sua fede in Dio e ancora a un filosofo, per aver pronunciato una bestemmia, diede un calcio nella pancia. Quando un protetto di Giuseppe Bonaparte, un certo Nardau inviato come prefetto a Parma ebbe la cattiva idea di dare un gran ballo il venerdì santo, fu destituito immediatamente. Alle rimostranze del fratello, Napoleone disse: ”il Nardau ha mostrato di non essere un uomo di governo, ma semplicemente un imbecille: per questo l’ho destituito”. Al generale Bertrand che metteva in discussione la divinità di Gesù, rispose:” Se lei non capisce che Gesù Cristo è Dio, ebbene ho sbagliato io a nominarla generale “ e ancora :” Ecco, a me gli effetti divini fanno pensare ad una causa divina, perché c’è una ragione superiore, un Essere infinito, che è la causa delle causa, ed è anche la causa della sua intelligenza. C’è un Essere infinito in confronto al quale lei non è che un atomo; in confronto al quale anch’io Napoleone, con tutto il mio genio, sono niente: lo capisce? Io lo sento, questo Dio, lo vedo, ne ho bisogno, credo in Lui. E se lei non crede, peggio per lei. Ma a me la cosa sta a cuore alla buon’ora, generale, lei crede in Dio!
Io perdono molte cose, ma ho orrore degli atei e dei materialisti. Cosa vuole che io abbia in comune con un uomo che non crede all’esistenza dell’anima, e che crede che l’uomo sia un mucchio di fango? Cosa vuole che io abbia in comune con un uomo che pretende che io sia, come lui pensa di essere, solo un mucchio di fango?”.
A Sant’Elena dispose che ogni domenica e ogni festa di precetto si celebrasse la Messa ed era solito inginocchiarsi davanti al Santissimo. Prima di morire si confessò e ricevette l’estrema unzione. Non la comunione per il timore che il vomito continuo gli facesse ricettare l’ostia sacra. Il suo testamento comincia così:” Io muoio nella religione Apostolica romana.
Secondo l’autorevole parere del cardinale Biffi, la figura di Napoleone presentata finora solo come materialista, saccheggiatore di chiese e di conventi, miscredente e fedifrago, anticlericale e sequestratore del Papa, va rivista. Era un uomo di fede, di una fede intesa come “adesione, non ad una teoria, ma ad una persona viva, Gesù”.
Fin qui la relazione di Antonino Megali ed a sostegno di quanto il relatore ha evidenziato sulla fede cattolica di Napoleone Bonaparte si riporta di seguito quanto scritto dal cardinale di Bologna Giacomo Biffi nella prefazione del saggio “ Conversazioni sul Cristianesimo” : «
Materialista e saccheggiatore di chiese e di conventi, miscredente e fedifrago, anticlericale e sequestratore del papa: questa è l’opinione che molti hanno di Napoleone Bonaparte, opinione tanto diffusa quanto acriticamente accolta. Se andiamo alle fonti, e in particolare a queste conversazioni,
scopriamo qualcosa di strabiliante. Napoleone grida con fierezza: «Sono cattolico romano, e credo ciò che crede la Chiesa» (infra p. 21). Durante gli anni di isolamento a Sant’Elena Napoleone si intratteneva spesso con alcuni generali, suoi compagni di esilio, a conversare sulla fede. Si tratta di discorsi improvvisati che – come rivela uno dei suoi più fidati generali, il conte de Montholon – furono trascritti fedelmente e poi dati alle stampe da Antoine de Beauterne nel 1840. Dell’autenticità e della fedeltà della trascrizione possiamo essere certi, visto che, quando de Beauterne pubblica per la prima volta le conversazioni, sono ancora in vita molti testimoni e protagonisti di quegli anni di esilio. Napoleone ammette con candida onestà che quando era al trono ha avuto troppo rispetto umano e un’eccessiva prudenza per cui «non urlava la propria fede». Ma dice anche che: «Allora se qualcuno me lo avesse chiesto esplicitamente, gli avrei risposto: “Sì, sono cristiano”; e se avessi dovuto testimoniare la mia fede al prezzo della vita, avrei trovato il coraggio di farlo» (infra p. 47). Soprattutto attraverso queste conversazioni impariamo che per Napoleone la fede e la religione erano l’adesione convinta, non a una teoria o a un’ideologia, ma a una persona viva, Gesù Cristo, che ha affidato l’efficacia perenne della sua missione di salvezza a «un segno strano», alla sua morte sulla croce. Perciò non ci stupiamo se Alessandro Manzoni nell’ode Cinque Maggio, composta pochi mesi dopo la morte di Napoleone, dà prova di conoscere la sua fisionomia spirituale quando scrive:
Bella Immortal! Benefica
Fede ai trïonfi avvezza!
Scrivi ancor questo, allegrati;
che più superba altezza
al disonor del Golgota
giammai non si chinò.
L’Imperatore si sofferma a lungo con il generale Bertrand, dichiaratamente ateo e ostile alle manifestazioni di fede del suo superiore, regalandoci un’inaudita prova dell’esistenza di Dio, fondata sulla nozione di genio, e una lunga conversazione sulla divinità di Gesù Cristo. Degni della nostra ammirazione sono anche le considerazioni sull’ultima Cena di Gesù e i confronti tra la dottrina cattolica e le dottrine protestanti. Alcune affermazioni di Napoleone mi trovano singolarmente consonante. Ad esempio, quando dice: «Tra il cristianesimo e qualsivoglia altra religione c’è la distanza dell’infinito» (infra p. 22), cogliendo così la sostanziale alterità tra l’evento cristiano e le dottrine religiose. Oppure la convinzione che l’essenza del cristianesimo è l’amore mistico che Cristo ci comunica continuamente: «Il più grande miracolo di Cristo è stato fondare il regno della carità: solo lui si è spinto ad elevare il cuore umano fino alle vette dell’inimmaginabile, all’annullamento del tempo; lui solo creando questa immolazione, ha stabilito un legame tra il cielo e la terra. Tutti coloro che credono in lui, avvertono questo amore straordinario, superiore, soprannaturale; fenomeno inspiegabile e impossibile alla ragione» (infra p. 44). Alla luce di queste pagine non possiamo non ammettere che Napoleone non solo è credente, ma ha meditato sul
contenuto della sua fede maturandone una profonda e sapienziale intelligenza. Questa a sua volta si è tradotta in fatti molto concreti: ha domandato con insistenza al governo inglese di ottenere la celebrazione della Messa domenicale a Sant’Elena; ha espresso gratitudine verso sua madre e de Voisins, vescovo di Nantes, perché da loro è stato «aiutato a raggiungere la piena adesione al cattolicesimo»; ha concesso il suo perdono a tutte le persone che lo hanno tradito (cf. Parte Seconda, p. 116 ed. fr.). Infine, le conversazioni riferiscono le convinzioni di Napoleone sul sacramento della confessione e i suoi rapporti con il papa Pio VII, rivelando che: «Quando il papa era in Francia, gli assegnai un palazzo magnifico a Fontainebleau, e 100.000 corone al mese; avevo messo a sua disposizione 15 vetture per lui e per i cardinali, anche se non uscì mai. Il papa era esausto per le calunnie in base alle quali si pretendeva che io lo avessi maltrattato, calunnie che il papa smentì pubblicamente» (infra p. 53). Queste conversazioni non solo hanno lasciato un segno indelebile nella memoria dei generali compagni di esilio, ma hanno anche concorso alla loro conversione. Lo stesso generale de Montholon ammette che: «L’Imperatore era cristiano; presso di lui, la fede era un fatto naturale ed essenziale; amava manifestare i propri sentimenti religiosi, anche in occasioni non formali. Era molto turbato quando gli capitava di assistere, o di evocare, comportamenti contrari alla religione. Allora, si dimostrava a disagio, non riusciva a celare il proprio malessere, la propria contrarietà e indignazione. Questo posso testimoniare, io che, durante la vita militare, avevo trascurato, e addirittura dimenticato la mia religione, che peraltro non praticavo affatto. All’inizio, questi comportamenti di Napoleone mi stupivano, ma gradualmente sono arrivato a una consapevolezza intima e profonda delle mie stesse convinzioni religiose. Ho visto la religiosità dell’Imperatore, e mi sono detto: “è morto nella religione, con il timore di Dio”. Anch’io invecchio, e la morte si sta avvicinando anche per me, e perciò vorrei morire anch’io come il mio Imperatore. Anche il generale Bertrand farà lo stesso percorso dell’Imperatore e mio, e anche lui diventerà credente come noi» (Parte Prima, pp. 19-20 ed. fr.). Ci auguriamo, quindi, che il rinnovato e attento ascolto di queste conversazioni renda onore alla memoria di Napoleone e ottenga frutti di conversione.» (13)


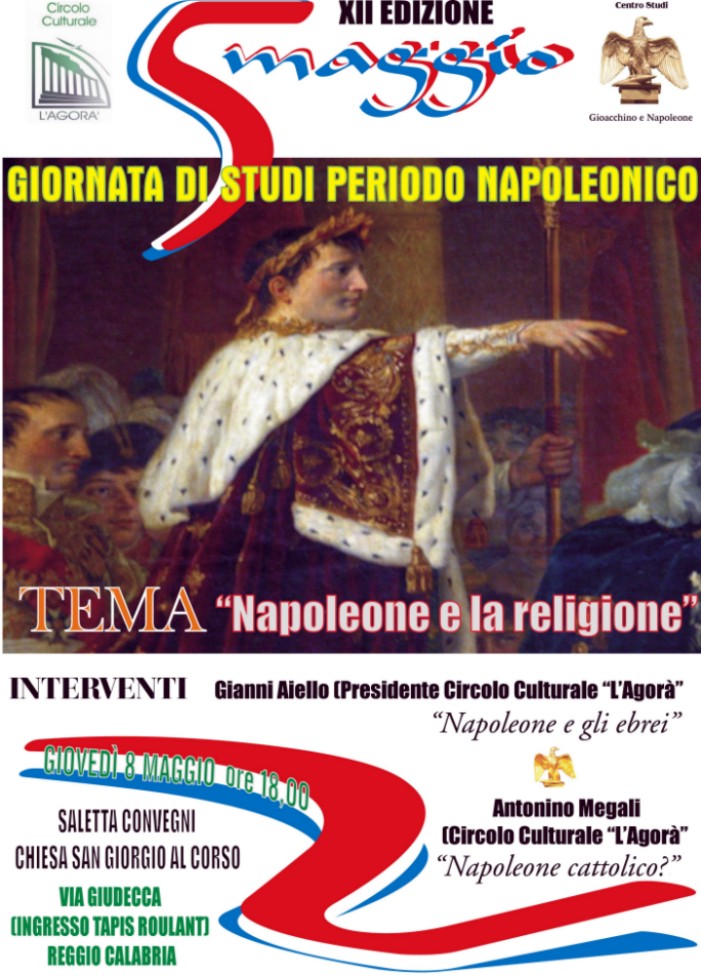

(1) Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel”, 22 maggio 1799
(2) Jaques Attali, "Les Juifs, le Monde et l'Argent ", pp. 423,424, Argo, 2003;
(3)Paolo Mieli, Corriere della Sera,11 dicembre 2012,pp 42,43
(4) http://spigolature-storiche.blogspot.it/2012/09/qe-i-cap-1-henri-gregoire-essi-sur-la.html
(5) Daniela Calligani (a cura di), “Napoleone e gli Ebrei. Atti dell'Assemblea degli Israeliti di Parigi e dei Verbali del Gran Sinedrio, con le lettere di Jacopo Carmi introdotte da Andrea Balletti (1806-1807), Analisi, 1991;
(6) Henry Graetz, “Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart:” (Storia degli Ebrei - Storia degli ebrei ), 3,4,capitolo XV, “Il Sinedrio di Parigi e la reazione” ( 1806-1815 ) , Leiner, 1900;
(7)René Gutman (a cura di) , “Le document fondateur du judaïsme français,
(Les décisions doctrinales du Grand Sanhédrin, 1806-1807)”, Università di Strasburgo, 2000;
(8) Pierre Birnbaum,”L'Aigle et la Synagogue: Napoléon, les Juifs et l'État”, Fayard,2007;
(9) Yves Bruley, “L'Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l'État in Historia”, n°726, juin 2007;
(10) http://www.morasha.it/ebrei_italia/ebrei_italia07.html
(11) Giuseppe Maria Croce, «Pio VII, il cardinal Consalvi e gli ebrei » in Giovanni Spinelli (a cura di), “Pio VII papa benedettino nel bicentenario della sua elezione. Atti del Congresso storico internazionale, Cesena-Venezia 15/19 settembre 2000”, Centro Storico Benedettino Italiano-Badia di Santa Maria del Monte, 2003;
(12) Emmanuel de Las Cases, “Il manoscritto pervenuto misteriosamente da Sant'Elena”, (a cura diLuigi Mascilli Migliorini), Bompiani,2004,